Esplora la Carta
Sorto in età normanna come residenza dei conti di Lecce e posto sul lato orientale della città, in corrispondenza delle mura urbane, il castello di età medievale, sulla base degli scavi archeologici effettuati negli ultimi anni, doveva pressoché corrispondere al corpo centrale quadrangolare del castello cinquecentesco, delimitato agli angoli sud-est e nord-est dalle due torri superstiti: la “Torre Maestra o Magistra” e la “Torre Mozza”. Documenti d’archivio riguardanti il castello menzionano, inoltre, una torre rotonda e un rivellino, dei quali però non si conosce la localizzazione. Dei tre ingressi ipotizzati solo uno è stato individuato con certezza, grazie al rinvenimento di strutture riconducibili al ponte levatoio e alla porta, sul lato rivolto verso la città nel punto che in seguito verrà occupato dalla Cappella di Santa Barbara. Il castello era circondato da un fossato che si congiungeva sul lato orientale al fossato che circondava la città. Gli ambienti relativi al castello medievale, ubicati sul lato nord e sud, dopo aver subito consistenti modifiche, furono inglobati nell’impianto del XVI sec. Sul lato orientale le due torri erano collegate da una cinta muraria di cui sono state rinvenute alcune tracce al di sotto delle strutture ora esistenti. Dal punto di vista archeologico, delle fasi più antiche del castello, relative al periodo normanno in cui conti di Lecce erano gli Altavilla, non abbiamo documentazione se non una struttura muraria della seconda metà del XII secolo rinvenuta durante gli scavi archeologici effettuati nel cortile. Con l’imperatore Carlo V, a partire dal 1539, avviene la ristrutturazione del maniero terminata probabilmente già nel 1553, anno di morte del vicerè Pietro de Toledo, il cui stemma campeggia al centro della volta della Sala Maria d’Enghien. Il castello viene munito, insieme alla città, di nuove opere difensive che rispondono alle rinnovate esigenze belliche, diventando emblema della grandezza imperiale, oltre che luogo di difesa contro gli attacchi nemici. Il progetto fu affidato all’architetto militare Gian Giacomo dell’Acaya, “Ingegnere Generale del Regno”. L’edificio subì una consistente ristrutturazione degli ambienti che costituiscono il nucleo interno, che andò ad inglobare la precedente struttura medievale, e un ampliamento delle sue dimensioni con la messa in opera di un’imponente cortina muraria che andava a collegarsi a quattro possenti bastioni: della S. Trinità e di S. Croce sul lato verso la città, di S. Martino e di S. Giacomo verso l’esterno. Il nuovo assetto a pianta trapezoidale con i quattro bastioni a punta di lancia agli angoli risulta così più adatto ad un sistema difensivo basato sul tiro radente, connesso alla recente introduzione delle armi da fuoco. La cinta bastionata esterna venne destinata alle esigenze militari di difesa, mentre il nucleo interno venne modificato e ristrutturato per assolvere alle importanti funzioni di residenza e di rappresentanza della corte che vi risiedeva. Al castello si accedeva dalla Porta Reale, sul lato rivolto verso la città, mediante un ponte levatoio che oltrepassava il profondo fossato che circondava la struttura sui quattro lati. Sul lato orientale, quello più sviluppato e fortificato, è invece collocata la c.d. “Porta Falsa” o “Porta del Soccorso”. Venuta meno la minaccia turca dopo la battaglia di Lepanto nel 1571, tutta la capillare opera di fortificazione del territorio voluta da Carlo V (ristrutturazione e edificazione di castelli, mura e torri costiere) si avviò verso una lenta ma inesorabile decadenza: lo stesso castello di Lecce, esaurito il ruolo difensivo che aveva avuto in passato, era diventato sostanzialmente inutile. Il declassamento della sua funzione militare lo portò tra la fine del ‘500 e gli inizi del ‘600 ad ospitare un modesto presidio spagnolo composto da un castellano e da cinquanta soldati; nelle “Cronache” del periodo si legge, inoltre, delle tragiche vicende vissute da alcuni personaggi che per debiti o omicidi furono rinchiusi nelle carceri del castello o giustiziati nel suo cortile. Su richiesta del Consiglio d’Italia, nel 1689, la guarnigione fu soppressa: i soldati furono distribuiti nelle altre fortezze e i carcerati trasferiti. Dal 1690 il castello fu sede del tribunale della Regia Udienza e nel corso del Settecento si ha notizia di un suo utilizzo come sede di civili abitazioni mentre per il salone fu proposto di impiegarlo per rappresentazioni teatrali.
Notizie storico-critiche:
- A partire dal 1870, per oltre un secolo, il castello vide la presenza di militari che ebbero nella sua struttura la sede del 5° Distretto Militare. In questo periodo il castello subì grandi trasformazioni. Nel 1872 fu definitivamente colmato il fossato e nell’area un tempo occupata da questo fu edificato un complesso di costruzioni teatrali: il teatro San Carlino (1908) immediatamente a lato dell’ingresso principale e, sul versante settentrionale, il teatro Politeama Greco (1884) e il teatro Apollo (1911). Il lato meridionale, invece, fu occupato nel 1898 dal Mercato Coperto con la tettoia liberty rimossa negli anni Ottanta e nel 1928 da una fontana monumentale che ricordava l’arrivo in città dell’acqua del Sele. Sul lato orientale la costruzione del Palazzo delle Poste nel 1927 ha tenuto conto dell’esigenza di arrecare il minor danno possibile alla prospettiva del castello e di consentire, eventualmente, il ripristino del fossato, che cingeva il castello stesso, e del ponte levatoio.
- La dismissione della “caserma-castello” e la cessione dell’immobile al Comune di Lecce nel 1983, insieme ai lavori di restauro a cui l’edificio è sottoposto in questi ultimi anni, stanno restituendo il monumento ai cittadini e ai visitatori della città che sempre più numerosi riscoprono questa struttura. Oggi il castello ospita in maniera permanente il Museo della Cartapesta, l’ala meridionale e orientale viene utilizzata per l’organizzazione di mostre temporanee, convegni, ed eventi culturali di vario genere.
- A seguito di politiche matrimoniali, Lecce e il suo territorio passarono agli Enghien e poi agli Orsini del Balzo, che regnarono e vissero a Lecce e nel suo castello. Sulla vita di corte che si svolgeva nel castello nei secoli precedenti l’età orsiniana non si dispone che di esigue tracce. È solo, infatti, a partire dalla morte di Maria d’Enghien, contessa di Lecce, e col passaggio della Contea a suo figlio Giovanni Antonio Orsini del Balzo, che la documentazione diventa più consistente, consentendo di conoscere il rapporto della famiglia regnante con il castello e il ruolo dello stesso maniero nell’amministrazione del principato. Il castello, infatti, oltre che disporre di una cappella, di una biblioteca e di un archivio dove conservare le copie miniate di opere importanti di letteratura, diventa sede degli uffici della cancelleria orsiniana.
- Il documento più antico che menziona una struttura castellare a Lecce è la Reparatio Castrorum redatta ai tempi di Federico II di Svevia, a metà del XIII secolo, periodo in cui la Contea era affidata alla famiglia dei Brienne. La ricostruzione del castello in quel periodo fa ipotizzare la presenza di una struttura precedente, di età normanna.
- AA. VV., Canestrini F. a cura di, Il Castello Carlo V. Tracce, memorie, protagonisti Galatina: Congedo Editore, 2014
- Tinelli M., Archeologia e storia nel castello di Lecce: notizie preliminari, Archeologia Medievale, XXXV, : , 2008
Scheda
- LEBIC000002
Tipologia del bene
Tipo: Castello (ambito urbano)
Criterio Identificazione: Il castello è di per sè una struttura composta da più parti con destinazione funzionale differente che insieme costituiscono un corpo organico.
Funzione:
- Abitativa/residenziale
- Difensiva/militare
Condizione Giuridica
Proprietà Ente pubblico territoriale
-
Tipo: Soprintendenze ambito archeologico
Ente: SABAP-LE (Archeologia)
Ruolo: Tutela e valorizzazione
-
Tipo: Soprintendenze ambito architettura-belle arti-paesaggio
Ente: SABAP-LE (Archite-BA-Pae)
Ruolo: Tutela e Valorizzazione
-
Luogo di collocazione/localizzazione [è contenuto in] - Sito
-
Luogo di collocazione/localizzazione [è contenuto in] - Sito
-
elemento contenuto in - Sito
Periodo:
- Età moderna (XVI -XVIII secolo)
- Età contemporanea (XIX-XXI secolo)
- Basso Medioevo (XI-XV secolo)
Motivazione:
- Analisi delle strutture
- Bibliografia
Cronologia specifica:
Dal: XII Al: XXI
- Restaurato
Criterio di perimetrazione: Si perimetra il profilo esterno della cortina muraria cinquecentesca del castello.
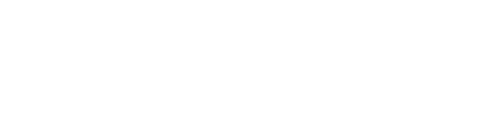








.JPG)
.JPG)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)