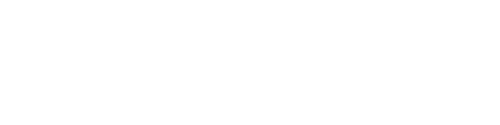Esplora la Carta
Agli inizi dell'Ottocento si assiste a cambiamenti funzionali di alcuni edifici: il convento dei Benedettini diviene sede degli Uffici Giudiziari, i Teatini divengono di proprietà comunale, il convento dei Celestini viene destinato agli uffici d'Intendenza, il convento del Carmine diventa sede della Compagnia scelta e provinciale, il monastero di S. Teresa è destinato a caserma della gendarmeria, il convento di S. Matteo è concesso alla città per l'archivio provinciale, per uso municipale e per le scuole, quello dei è adibito a sede della manifattura tabacchi. Durante la restaurazione borbonica (1815-1860) continua la realizzazione di spazi necessari al funzionale svolgimento della vita amministrativa. Inizia la sistemazione dell'area suburbana immediatamente a ridosso delle mura, con la costruzione dei viali alberati. Viene inaugurato il primo tratto (Lecce – Campi) della nuova strada provinciale Lecce – Taranto; l'inizio della nuova “Strada Ferdinandea” viene enfatizzato dall'obelisco eretto in onore del sovrano al centro di una piazza circolare. Viene abbattuta Porta San Martino e un tratto delle mura regolarizzando il prospetto posteriore dell'Intendenza. Il giardino pubblico (la “Villa”), istituito sin dal 1818, riceve una prima sistemazione e si delibera la costruzione della strada verso il mare e l'approdo di S. Cataldo. Al problema dell'igiene, in conformità con le disposizioni impartite da Ferdinando I nel 1817, si lega anche la costruzione del complesso monumentale del cimitero all'esterno di Porta Napoli. Nel corso dell'Ottocento vengono aperti nuovi assi stradali, si assiste a numerose rettifiche con la motivazione di nuovo decoro urbano, di sicurezza, di pubblica incolumità e di igiene. L'allargamento delle sedi stradali comporta la perdita di buona parte degli antichi fronti edilizi. Intorno alla metà dell'Ottocento si realizzano numerosi esempi di sventramenti con la creazione di nuovi spazi pubblici e assi stradali; tali interventi si concentrano in alcuni settori chiave della città, come l'ambito di Porta Napoli, quello in prossimità della futura piazza Sant'Oronzo e lo slargo ricavato di fronte alla chiesa di S. Chiara. Fra gli interventi di rifunzionalizzazione di edifici esistenti, il caso più emblematico riguarda l'ex complesso conventuale francescano di S. Giuseppe (attuale Convitto Palmieri), che subisce una serie di modifiche che portano a una trasformazione radicale dell'immagine esterna del fabbricato e della sua distribuzione interna. Dopo l'Unità di Italia vengono compiute tre opere pubbliche primarie: la strada interna di fronte a porta Napoli, il taglio di casa Bonavoglia per un rapido collegamento fra i Benedettini e la Prefettura, e la rettifica del lato orientale della piazza dei Mercanti, dalla casa Farina alla chiesa delle Grazie. La stagnazione economica della città nel corso della seconda metà dell'Ottocento non pone, infatti, le condizioni per un ampliamento di qualche rilevanza. Alla fine del secolo si assiste alla demolizione di due rappresentative porzioni città: l'Isola del Governatore e la caserma S. Martino (ex Regia Udienza), per fare posto alle sedi di due importanti istituti di credito (rispettivamente la Banca d'Italia e il Banco di Napoli). Nel corso dei lavori per la costruzione della Banca d'Italia viene individuato e portato parzialmente alla luce l'anfiteatro romano. Sul fronte orientale, dominato dalla presenza del Castello, il punto di partenza delle iniziative è costituito dal riempimento dei fossati. La prima costruzione ad addossarsi alle pareti della fortezza (lato N) è rappresentata dal teatro Politeama Greco, cui segue nel 1898 il mercato coperto (lato S). In corrispondenza del lato est, invece vengono tracciati i confini dell'ampio piazzale intitolato al Castromediano, edificato solo più tardi con il palazzo delle Poste. Per il resto, fra la fine dell'Ottocento e i primi anni del secolo scorso, la Lecce storica è caratterizzata da una miriade di interventi che, per il loro numero, finiscono per incidere in maniera profonda sul disegno della città. In assenza di un Piano Regolatore che incentivi e regoli lo sviluppo urbano extra moenia, vengono proposti alcuni piani parziali per disciplinare i nuovi borghi che si vanno via via sviluppando. Durante il ventennio fascista Lecce vive, pur tra squilibri e contraddizioni, una stagione di cambiamento e di parziale modernizzazione, che porta alla costruzione di nuovi edifici secondo i canoni della rappresentanza che il regime vuole dare di sé. Nel 1933 risulta in avanzata fase di realizzazione la rete, completati e inaugurati l'Acquedotto Pugliese (con la realizzazione della fontana dell'Armonia), il Palazzo delle Poste, la casa del Mutilato e l'antistante monumento ai caduti. Nel 1929, durante lo scavo delle fondamenta di una casa fra i giardini dei palazzi Romano e D'Arpe, in vico de' Marescalli, vengono rinvenuti i resti del teatro romano, sistemati nel 1938. Negli anni seguenti, si conferma la tendenza a considerare i viali intorno alle mura, cui si aggiunge l'area di piazza S. Oronzo, quali luoghi destinati alla celebrazione dei “fasti” del regime attraverso la realizzazione di nuove opere. Nel 1940 risultano realizzati il nuovo teatro di via Vito Fazzi, il Regio Istituto Magistrale, il nuovo Banco di Napoli; l'Istituto Nazionale Fascista Infortuni, la Casa Littoria, il palazzo del Consiglio Provinciale delle Corporazioni ed i palazzi INCIS lungo viale Gallipoli; il Liceo Musicale Tito Schipa; la casa della Madre e del Bambino, la Regia Questura e il Provveditorato agli Studi lungo il viale di circonvallazione di recente costruzione. Relativamente all'area di piazza S. Oronzo, risalgono agli anni a cavallo tra il '35 e il '38 la demolizione degli isolati dietro al Sedile per la costruzione del nuovo Palazzo, il palazzo dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza, lo sterramento dell'anfiteatro, la demolizione dell'isola delle “Capande”, la costruzione del nuovo fronte settentrionale della piazza, lo spostamento della colonna e la rotazione di 180° della statua del santo.
Notizie storico-critiche:
- Dopo l’unità d’Italia tra il 1895 ed il 1925 la città si estende oltre le mura cinquecentesche. Con l’Unità d’Italia il Sud, nella fallimentare situazione finanziaria, inizia ad assolvere il ruolo di “novella colonia”. All’indomani della grande guerra la provincia di Lecce, comprendente anche Taranto (separata nel ’23) e Brindisi (separata nel ’26) costituisce la realtà territoriale più estesa della regione e risulta fra le più popolate in assoluto; al dato demografico fa da contraltare tuttavia la perdurante arretratezza della subregione salentina. Durante il ventennio fascista Lecce vive, pur tra squilibri e contraddizioni, una stagione di cambiamento e di parziale modernizzazione, che porta alla costruzione di nuovi edifici secondo i canoni della rappresentanza che il regime vuole dare di sé.
- Nel gennaio 1799 i soldati francesi fanno il loro ingresso nel Regno. L’8 febbraio viene dato a Lecce “l’avviso di Repubblica, cioè della uguaglianza e della libertà”.?I fatti del ’99 costituiranno un evento importante per la storia del Mezzogiorno; le successive ed alterne vicende della presenza militare francese in Terra d’Otranto, fra il 1801 ed il 1805, si concludono con l’occupazione definitiva del Regno nel febbraio 1806. A Lecce, a soffrire maggiormente per la presenza di truppe di occupazione (accompagnata dalla soppressione degli ordini religiosi e l’incameramento da parte dello stato dei beni delle corporazioni) sono le strutture conventuali, destinate all’accasermamento o ad altri servizi di pubblica utilità.
- Fagiolo M., Lecce. Architettura e storia urbana Galatina: Congedo Editore, 2013
- De Stefano M., Lecce. Riqualificazione e valorizzazione ambientale, architettonica e archeologica del centro storico, Lecce. Riqualificazione e valorizzazione ambientale, architettonica e archeologica del centro storico, , Roma: De Luca Editori d'Arte, 2004
- Siciliano S., Ieri e oggi in Piazza. Bene culturale e contemporaneità attraverso la fotografia in Piazza Sant’Oronzo a Lecce Galatina: , 2003
Scheda
- LEBIS000691
Tipologia del bene
Tipo: Città
Funzione:
- Sacra/religiosa/culto
- Produttiva/lavorazione/artigianale
- Abitativa/residenziale
Condizione Giuridica
Proprietà mista pubblica/privata
-
Tipo: Soprintendenze ambito architettura-belle arti-paesaggio
Ente: Sop. Belle Arti BR-LE
Ruolo: Tutela e valorizzazione
-
elemento contenuto in - Sito Pluristratificato
Periodo:
- Età contemporanea (XIX-XXI secolo)
Motivazione:
- Analisi delle strutture
- Analisi stilistica
- Fonte archivistica
- Integro
Criterio di perimetrazione: Il criterio di perimetrazione si basa sullo sviluppo edilizio attuale della città che comprende le varie evoluzioni storiche dell'impianto urbanistico.
Tipo Fruibilità: Aperto al pubblico