Esplora la Carta
La cattedrale, che costituisce uno dei capisaldi del Romanico pugliese e in particolare del Romanico di Capitanata, fu fondata dal vescovo Girardo (1093-1097) e ha conosciuto complesse fasi costruttive che hanno raggiunto il completamento in epoca pienamente duecentesca. Una importante campagna di lavori si deve al vescovo Guglielmo II (1108-1141), il quale arricchì il patrimonio della cattedrale con ingenti donativi di codici, di suppellettili liturgiche e di paramenti sacri. L’edificio a pianta longitudinale è diviso in tre navate da due filari di sei colonne di granito e di pietra lucidata - tutte di reimpiego: alcune monolitiche, alcune formate da vari pezzi - arricchite da capitelli medievali finemente decorati. La prima colonna di destra è duplicata: caratteristica che non sembra avere funzione statica bensì simbolica (la tredicesima colonna simboleggerebbe Cristo, pietra angolare della chiesa e capo del consesso dei dodici apostoli). All’incrocio dei bracci del transetto si trova una struttura retta da pilastri polistili: a causa di alcune incongruenze costruttive, parte della critica ipotizza che si tratti di murature preesistenti, forse da riferire alla prima cattedrale (attestata nel 1030). Il presbiterio – decorato da pitture di Giuseppe La Rosa nella seconda metà del XVII secolo – è concluso da un’unica abside. L’attuale transetto è frutto di interventi settecenteschi; a seguito del terremoto del 1731 era crollata la Cappella di Santa Lucia, con il braccio sinistro del transetto (l’unico esistente fin dal medioevo) e fu eretta la Cappella dei Santi Patroni (1732-1738), mentre il braccio destro fu costruito nel 1774, con la Cappella della Vergine. Queste cappelle sono decorate con marmi policromi ed arricchite da altari barocchi opera di marmorari napoletani; quella dei Santi Patroni era impreziosita da busti argentei attualmente custoditi nel Tesoro (i busti di Sant’Eleuterio e Sant’Urbano sono opera di Ignazio d’Urso, fra 1692 e 1698; il busto di Sant’Anastasio si deve a Andrea de Blasio, all’inizio del XVIII secolo; non è noto l’autore del busto dei Santi Secondino e Ponziano). Sulla parete di fondo del presbiterio, a sinistra dell’abside, è affrescata una monumentale Dormitio Virginis, databile al XV secolo. Dell’arredo liturgico originario sopravvive l’ambone, datato 1169. La facciata, celebre per la sua scansione ad arcate cieche decorate da losanghe e tondi – spesso considerate dalla critica una derivazione del romanico pisano –, è scandita in due registri da un imponente cornicione classicheggiante su mensole. Il registro superiore è stato ritessuto in epoca gotica con l’inserimento del superbo rosone. Questo intervento è ritenuto, da alcuni, di epoca federiciana (probabilmente non estraneo alla committenza del filosvevo Gualtiero di Palearia) mentre, da altri, è ritardato all’epoca angioina. Il portale di facciata e quello del fianco destro sono impreziositi dalle due straordinarie porte bronzee realizzate da Oderisio da Benevento, rispettivamente nel 1119 e nel 1127, su impulso del vescovo Guglielmo II: il loro complesso programma iconografico celebra la storia di Troia e dei suoi santi patroni. Nel corso dei secoli sono state oggetto di vari interventi di restauro che hanno, talvolta, comportato la sostituzione di alcune formelle. La decorazione delle pareti esterne e della facciata fu, a sua volta, realizzata in vari momenti: più antico sembrerebbe il completamento del fianco destro, caratterizzato dalla presenza di losanghe e da formelle arricchite da intarsi geometrici policromi. Il fianco sinistro appare più ricco e articolato con l’utilizzo di un’elegante plastica architettonica di matrice orientale - bizantina e islamica - che sembra comportare una datazione al maturo XII secolo. Dal 1986 è stata istituita la diocesi Lucera-Troia e l’edificio è divenuto concattedrale.
Notizie storico-critiche:
- La cattedrale fu fondata nel 1093 dal vescovo Girardo da Piacenza sulla preesistente chiesa di Santa Maria.
- I lavori, ritardati dall'incendio del 1098 che devastò l'intera citta' di Troia, furono ripresi e portati a termine sotto il vescovado di Guglielmo II (1106/1127).
- Nella seconda metà del 1700 monsignor Marco De Simone (1752/1777) provvide alla realizzazione del braccio destro del transetto. Il progetto e la direzione dei lavori furono affidati all'architetto napoletano Filippo Fasulo.
- Nel 1734 viene demolito l'originario braccio sinistro del transetto e ricostruito nella forma odierna su progetto dell'architetto napoletano Giustino Lombardi.
- Sotto il vescovado di mons. Antonio Di Sangro (1676/1682), la cattedrale, pressoché cadente ed esposta alle intemperie, fu soggetta a radicale restauro. Il Di Sangro fece inoltre decorare, sotto la direzione del pittore Giuseppe De Rosa da Squillace, gli interni della chiesa con affreschi e stucchi.
- Nel corso del 1400 e del 1500 le navate laterali furono corredate da una serie di altari e cappelle.
- Tra la fine del XII secolo e l'inizio del XIII, la chiesa subì una seriedi rimaneggiamenti strutturali e formali, quali l'abbattimento della vecchia chiesa di S. Maria, la trasformazione in "senso gotico" della parte superiore della facciata principale e il rivestimento con arcatelle cieche della parte alta dei prospetti laterali.
- Gli altari e le cappelle costruiti tra il 1400 e il 1500 vengono demoliti nella seconda metà del 1800.
Definizione Ambito Culturale:
- Dato non disponibile
- Belli D'Elia P., Puglia romanica : EDIPUGLIA, 2003
- Gelao C., Jacobitti G. M. a cura di, Castelli e cattedrali di Puglia : Adda Editore, 1999
- Fonseca C.D., Cattedrali di Puglia. Una storia lunga duemila anni Bari: Adda Editore, 2001
- De Santis M., La "civitas troiana" e la sua cattedrale, La "civitas troiana" e la sua cattedrale, , Foggia: , 1986
- AA. VV., Martin J. M. a cura di, Troia nel primo millennio, Troia nel primo millennio, , Foggia: Claudio Grenzi Editore, 2019
- Massimo G., Gravina Armando a cura di, L'uso del colore nell’architettura di epoca normanno-sveva dell’Italia meridionale: analisi di alcuni casi di studio, Atti del 39°Convegno Nazionale sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia, San Severo 17 - 18 novembre 2018, , Foggia: , 2019
Scheda
- FGBIU001187
Tipologia del bene
Tipo: Chiesa
Funzione:
- Sacra/religiosa/culto
Condizione Giuridica
Proprietà Ente religioso cattolico
-
Tipo: Soprintendenze ambito architettura-belle arti-paesaggio
Ente: Sop. Belle Arti BA-BAT-FG
Ruolo: Tutela e valorizzazione
-
Tipo: Soprintendenze ambito architettura-belle arti-paesaggio
Ente: SABAP-FG (Archite-BA-Pae)
Ruolo: Tutela e valorizzazione
-
Bene composto [è riutilizzato da] - Sito
-
Bene composto [è riutilizzato da] - Sito
-
elemento contenuto in - Sito
Periodo:
- Basso Medioevo (XI-XV secolo)
- Età moderna (XVI -XVIII secolo)
- Età contemporanea (XIX-XXI secolo)
Motivazione:
- Bibliografia
Cronologia specifica:
Dal: XI sec.
- Integro
- Restaurato
Tipo Fruibilità: Edificio di culto
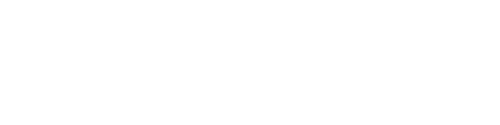








.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)