Esplora la Carta
Il Castello attuale è frutto delle diverse modifiche apportate dai vari proprietari dal XVII al XX secolo. Pur conservando la forma quadrangolare della pianta e del cortile interno, nel Seicento, infatti, una serie di restauri ad opera dei De Angelis impressero al Castello un volto barocco: furono realizzate finestre ricche di ornati barocchi e di stucchi lungo le cornici di bordura e furono costruiti i piani superiori dove si apre un immenso salone, un tempo dotato di un sottocielo dipinto da Luca Paciolla. Le sale al primo piano erano adibite ad appartamenti nobili: c La “Gran Sala”, che costituiva la stanza di rappresentanza, con copertura a capriate lignee con travi a vista, e con le pareti decorate con preziosi affreschi, raffiguranti stemmi di casate nobiliari; la cappella privata, alla quale si accede dal lato meridionale della Gran Sala, una piccola stanza dalle pareti riccamente decorate con stucchi; le camere dei signori sul lato nord (piazza Orsini del Balzo), quelle degli ospiti sul lato nord, le stanze della servitù, le cucine, il loggiato coperto e la loggia coperta. Tutte queste stanze si affacciano sia sul cortile interno, l'antica piazza d'armi, sia all'esterno, attraverso il quale si aveva accesso alla rimessa, ad un magazzino e alla stalla. La corte interna, dalla quale è possibile accedere alla zona superiore esterna relativa al giardino pensile che si affaccia sul lato est del castello, è impreziosita da portali bugnati a tutto sesto, di epoca rinascimentale. Le facciate Est e Nord sono interamente percorse da un'ampia loggia rinascimentale; nella parte bassa le mura della torre sono a scarpata, ma anche il suddetto torrione oggi è ingentilito da una serie di finestre barocche al secondo piano e da una merlatura di fantasia. Nell’ala occidentale del castello, esattamente sopra la cantina, fu fatto costruire nel 1661 (data riportata su un frammento di mosaico collocato sul pavimento) dal principe Giovanni Antonio Albricci un loggiato che nel Seicento era coperto da un grande tetto in legno, sorretto da una duplice fila di colonne. Sull'ingresso principale del castello sono visibili il portale rinascimentale con i conci lavorati a punta di diamante e sulla destra le due archibugiere, le antiche bocche di fuoco. Nei sotterranei del Castello furono costruite, tra il Cinquecento e il Seicento, sei cisterne per la conservazione dell’olio e del vino, delle quali l’ultima non è più visibile, essendo stata murata negli anni ’50 per problemi di stabilità della torre. Ogni cisterna è rivestita nella parte inferiore con pietra calcarea impermeabile e, in quella superiore, con carparo o tufo, materiali piuttosto porosi: ciò fa supporre che queste vasche fossero riempite soltanto fino ad un determinato livello. In corrispondenza delle bocche attraverso cui l’olio veniva introdotto nelle cisterne ci sono le pozzette di decantazione per raccogliere gli scarti dell’olio, che si depositavano sul fondo. I fori che si osservano nelle pareti, si rendevano forse necessari per il ricambio dell’aria nella cisterna. Le porte di comunicazione fra le cisterne sono state aperte di recente, per rendere questi ambienti visitabili. All’interno del Castello, sempre nei sotterranei, erano due neviere per l’immagazzinamento del ghiaccio, una collocata sotto il pavimento della stanza sulla sinistra dell’ingresso principale e l’altra sul lato nord-ovest del castello, in corrispondenza dell’attuale sala mostre.
Notizie storico-critiche:
- Per il periodo aragonese si ha la testimonianza del letterato Cataldantonio Mannarino che, nel suo manoscritto del 1596, ci tramanda che il nucleo più antico del Castello, pericolante, fu abbattuto da Giovanni Antonio Orsini del Balzo intorno alla seconda metà del Quattrocento e che al suo posto fu costruita l’attuale torre quadrata, circondata da un fossato profondo due metri e largo nove. Oggi non è più presente il fossato originale, sul quale si apriva il pone levatoio dal lato dell'attuale sala auditorium, considerando la posizione delle caditoie ancora visibili. Lo storico elaborò anche una pianta dalla quale si deduce che nel 1596 il centro storico si sviluppava attorno alla torre collocata su un’altura e circondata da una cinta muraria che comprendeva 22 torrette difensive.
- Nel 1750 quando per riparare i danni subiti dal terremoto del 20 febbraio 1743, il marchese Barretta, feudatario dell’epoca, fece abbattere muri pericolanti, modificare le finestrature della torre e aprire le otto arcate della zona al primo piano a settentrione. Il terremoto distrusse parzialmente anche il “Polledro”, un’antica torretta che sovrastava il torrione principale, che pertanto fu abbattuta.
- Nel 1630 fu abbattuta la parte occidentale del Castello dal principe Albricci, che ne fece un porticato rinascimentale.
- Mesagne agli inizi dell’XI secolo era sotto il dominio bizantino; nel 1062 la Puglia fu conquistata dai normanni e a quella invasione risale forse la fondazione del “castrum” di Mesagne. Il termine appare per la prima volta nell’opera Rerum Italicarum Scriptores di Ludovico Antonio Muratori, il quale scrive che “il duca Roberto conquistò di nuovo Brindisi […] e fece un castrum a Mesagne”. Indipendentemente dall’autenticità di questa cronaca si presume che già dal periodo bizantino esistesse un luogo fortificato o castrum, necessario per controllare questo importante territorio. Il Castrum fu distrutto nel 1256 con le devastazioni dei saraceni assoldati da Manfredi lo Svevo, durante le lotte tra Guelfi e Ghibellini.
- I restauri del duca Barretta interessarono gran parte del castello a cominciare dalle finestre del primo piano, tutte decorate, e all’esterno con stucchi; le famiglie dei marchesi Imperiali prima e dei Granafei successivamente, rimaneggiarono la costruzione per adibirla a propria abitazione.
Definizione Ambito Culturale:
- Periodo settecentesco
- A. Nitti, Mesagne e dintorni. Itinerari storico-artistici, Mesagne e dintorni. Itinerari storico-artistici, , Manduria (TA): Tiemme-Industria Grafica, 2004
- D. Urgesi, Il castello di Mesagne nelle fonti storiche e documentarie, Studi e ricerche della Biblioteca Comunale Ugo Granafei, 4, Mesagne (BR): , 1998
- A. Profilo, Vie, Vichi, corti e piazze di Mesagne, Vie, Vichi, corti e piazze di Mesagne, , Ostuni (BR): , 1894
- A.C. Leopardi, A.C. Leopardi a cura di, Robertus dux fecit castrum in Meana, Robertus dux fecit castrum in Meana, , Bari: , 1981
- D. Urgesi, La guida di Mesagne, Studi e Ricerche della Biblioteca Comunale Ugo Granafei, , Mesagne: , s.n.
- Jurlaro R., Storia dei monumenti brindisini, Storia dei monumenti brindisini, , Brindisi: Amici della "A. de Leo", 1976
Scheda
- BRBIU000238
Tipologia del bene
Tipo: Palazzo
Funzione:
- Abitativa/residenziale
- Difensiva/militare
Condizione Giuridica
Detenzione Ente pubblico territoriale
-
Tipo: Soprintendenze ambito architettura-belle arti-paesaggio
Ente: Sop. Belle Arti BR-LE
Ruolo: Tutela e valorizzazione
-
Luogo di collocazione/localizzazione [è contenuto in] - Complesso Topografico
-
Luogo di collocazione/localizzazione [è contenuto in] - Sito
-
elemento contenuto in - Sito
Periodo:
- Età moderna (XVI -XVIII secolo)
Motivazione:
- Analisi stilistica
- Bibliografia
- Restaurato
Dimensioni in Mq: 2611.00
Tipo Fruibilità: Attrezzato per la fruizione
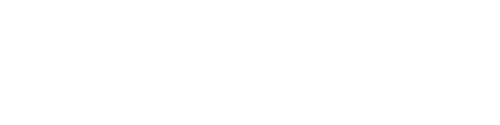








.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)