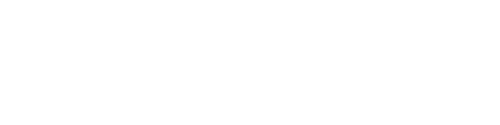Esplora la Carta
L'antica città di Arpi è stata localizzata con certezza a circa 6 km a Nord Est da Foggia, in un'area che conserva per diverse località il toponimo antico (San Nicola d'Arpi, Posta Arpi, ecc.); gli autori antichi, che ne fanno risalire la fondazione a Diomede, ne tramandano anche i diversi nomi assunti nel corso della sua storia (Argos Hippios, Argyrippa, infine Arpi). Nel 1957 il Bradford potè riconoscere, tramite l'aereofotografia, il perimetro della fortificazione ad aggere che circondava l'insediamento antico su tre lati: il versante Nord Ovest era invece naturalmente difeso dal Celone. Per l'Età del Ferro la nostra conoscenza della vicenda insediativa del sito è scarsa. L'unico fossile guida per la ricostruzione storica è costituito dalle tombe, rinvenute in più punti entro l'area più tardi cinta dalla fortificazione: la più antica è a fossa, con copertura a tumulo (diametro m 4,50), databile all'VIII sec. a.C. Per il VII-VI sec., oltre ad alcune tombe (è stata scavata in particolare la necropoli di località Montarozzi, in cui le sepolture – a fossa o a grotticella – spaziano dal VI al III sec. a.C.) e a un frammento di stele daunia (che attesta anche ad Arpi l'impiego del manufatto, di probabile destinazione funeraria, diffuso in molti centri della Daunia, soprattutto a Cupola-Beccarini e Salapia), è attestata anche una capanna. Un momento di netta definizione dello spazio insediativo si ha con la costruzione della cinta difensiva. Essa si sviluppava per ben 13 km, racchiudendo un'area vastissima, calcolabile intorno ai 1000 ettari. La cronologia di quest'opera fortificatoria è stata collocata nel pieno VI sec. a. C.; una seconda fase costruttiva è stata datata su base stratigrafica alla fine dello stesso secolo, quando il fossato fu ricoperto, e al di sopra del terrapieno venne elevato un muro di mattoni crudi. Per l'area delimitata dalle fortificazioni si ricostruisce un'occupazione secondo il modello insediativo “sparso”, ben noto per gli abitati dauni arcaici: nuclei di villaggi (in cui le unità abitative erano costituite da capanne, più o meno grandi, con fondazioni in pietra, alzato in legno e strame) e di necropoli si distribuivano in maniera sparsa, puntiforme, nel vasto territorio, accanto ad aree lasciate libere per le coltivazioni, il pascolo e l'allevamento. Ciò spiega anche perchè, nonostante i numerosi scavi effettuati all'interno della cerchia difensiva, sull'abitato arcaico si sappia molto poco. Importante appare tuttavia, come spia seppure isolata dei processi di strutturazione dello spazio urbano (o, con un termine spesso applicato alla realtà insediativa daunia, “proto-urbano”), un fregio fittile di età tardoarcaica (fine VI sec. a. C.), con choròs di figure femminili che si tengono per mano, rivenuto al di sotto della cd. “Casa dei grifi e delle pantere” di località Montarozzi. Il fregio, che per quanto riguarda il soggetto è di chiara derivazione magnogreca, è da riferire a un'architettura di prestigio, molto probabilmente di funzione religiosa, e va collocato pertanto in quella serie di testimonianze, costituite ora da lacerti di strutture monumentali ora dai resti della decorazione architettonica (antefisse, sime) di edifici sacri e/o politici (tra i due ambiti, com'è noto, non è possibile tracciare una distinzione netta per l'età arcaica) attestati nello stesso orizzonte cronologico anche in altri insediamenti dauni, per es. a Canosa-San Leucio, Canosa-Toppicelli, Canne-Fontanella, o a Tiati. Si può assistere dunque anche ad Arpi, sullo scorcio del VI sec. a. C., all'emergere di un'architettura sacra di un certo impegno edilizio, che segna dei luoghi di culto destinati a diventare poli di aggregazione sia in relazione alla stessa civitas daunia sia al territorio circostante e alle gentes vicine. L'organizzazione insediativa arcaica subisce una modifica sostanziale a cavallo tra il IV e il III sec. a. C., analogamente a quanto la fenomenologia archeologica permette di osservare a Canosa, Ordona, Tiati, Lavello, Banzi. L'enorme abitato subisce un drastico restringimento; la scomparsa del sistema insediativo sparso di età arcaica si accompagna (per quanto si può dire da una documentazione ancora per più rispetti lacunosa) a una ripartizione funzionale degli spazi (privati, pubblici, sacri, cimiteriali – questi ultimi ora esterni all'abitato). Dell'assetto viario, solo molto parzialmente intercettato dallo scavo stratigrafico, sembrano però restare cospicue tracce individuabili con l'aereofotografia, che mostrano una fitta rete stradale, con percorsi viari sia rettilinei sia tortuosi, non organizzati secondo principi stricto sensu “regolari” (almeno non dappertutto: lo scavo del quartiere ellenistico di località Montarozzi sembra mostrare una certa ratio nell'organizzazione della maglia viaria); al documento archeologico è stata affiancata la testimonianza liviana, che di Arpi ricorda le viae tenebrae et angustae. Al nuovo assetto insediativo, che in definitiva assume per la prima volta dei connotati urbani – il fenomeno, osservabile nella maggior parte dei grandi abitati dauni, è stato considerato il portato più significativo, a livello urbanistico, della romanizzazione -, si accompagna una documentazione archeologica più consistente per quanto riguarda soprattutto l'edilizia residenziale di IV e III sec. a. C. Negli esempi più articolati e monumentali, le domus sono da ricondurre a quei ceti emergenti arpani che vediamo allearsi con Roma nel 326 a. C., e che mostrano – analogamente a quanto avviene per i monumentali ipogei contemporanei – l'assimilazione di elementi culturali di matrice greca. In località Montarozzi sono state scavate le dimore di età ellenistica più ricche e meglio documentate, come la “casa a peristilio” o “del mosaico dei grifi e delle pantere”, con elaborata planimetria e grandi mosaici a ciottoli di fiume; strutture abitative coeve più semplici sono state indagate in contrada Menga, dove si deve ravvisare anche un quartiere artigianale. Le tombe a camera, appannaggio della società aristocratica arpana di età ellenistica, sembrano risentire soprattutto dell'influenza culturale dell'area greco-settentrionale, cioè della Macedonia, sia nell'architettura del sepolcro, sia nel ricco apparato decorativo pittorico. Il più noto e meglio studiato è l'ipogeo della Medusa (impianto iniziale del III sec. a. C., utilizzato fino a tutto il II sec. a. C.), ma il quadro è nel complesso ben documentato e si è arricchito in anni recentissimi con la scoperta dell'ipogeo cd. “della Nike” in località Montarozzi.
Definizione Ambito Culturale:
- Dato non disponibile
- Guaitoli M. a cura di, Lo sguardo di Icaro. Le collezioni dell'Aerofototeca Nazionale per la conoscenza del territorio : Campisano, 2003
- Mazzei M., Nella Daunia antica, ,2004
- Mazzei M., Arpi. L'ipogeo della Medusa e la necropoli : EDIPUGLIA, 1995
- Mazzei M., L'ipogeo della Nike di Arpi. Nota preliminare., Annali di archeologia e storia antica. Dipartimento di studi del mondo classico e del Mediterraneo antico., 9-10, Napoli: , 2002-2004
- Mazzei M., Arpi Preromana e romana i dati archeologici: analisi e proposte di interpretazione, TARAS, IV, 1-2, : , 1984
- Mazzei M., Guaitoli M. a cura di, Arpi, Foggia, Lo sguardo di Icaro. Le collezioni dell’Areofototeca Nazionale per la conoscenza del territorio, , : Campisano, 2003
Scheda
- FGBIS002270
Tipologia del bene
Tipo: Insediamento
Funzione:
- Produttiva/lavorazione/artigianale
- Abitativa/residenziale
Condizione Giuridica
Dato non disponibile
-
Tipo: Soprintendenze ambito archeologico
Ente: Sop. Archeologia Puglia
Ruolo: Tutela e valorizzazione
-
elemento contenuto in - Sito Pluristratificato
Periodo:
- Età Arcaica (VII-VI sec. a.C.)
- Età Ellenistica (IV-I sec. a.C.)
- Prima età del Ferro (1.000-700 a.C.)
- Età Classica (V-IV sec. a.C.)
Motivazione:
- Analisi delle strutture
- Bibliografia
- Materiali
- Asportato in seguito a scavo
- Indeterminabile
Criterio di perimetrazione: Area determinata in seguito all'analisi delle fotografie aeree.
Tipo Fruibilità: Non fruibile