Esplora la Carta
La masseria, destinata essenzialmente all'allevamento di pecore, si è mantenuta pressoché integra nella sua struttura essenziale, nonostante gli ampliamenti avvenuti in epoca successiva, che non ne hanno comunque alterato l'organismo originario. Questo doveva far parte di un vasto complesso massariale, appartenente alla famiglia Barone, articolato in una serie di strutture produttive e servizi come la "Panetteria di Barone" e la "Vaccareccia S. Lucia", formata da una serie di stalle a portico, da magazzini, da un ambiente per la preparazione del formaggio e dall'alloggio per il vaccaro. Tutti questi organismi, separati ma in stretta correlazione fra loro, concorrevano a formare un sistema aziendale di notevoli proporzioni, il cui nucleo principale era costituito dalla "Posta Torre Bianca", con il palazzo del signore in posizione predominante. Le torri, con la tipica forma a calice, costituiscono gli unici elementi che conferiscono un certo carattere all'architettura semplice e lineare di questo edificio. La costruzione è realizzata in murature di pietrame alternato a filari di mattoni di argilla; le due torrette e parte dell'edificio addossato esternamente alla scala di collegamento sono in blocchi di tufo. Sul lato sudoccidentale rispetto alla masseria è presente una piccola cappella, a navata unica, caratterizzata da una facciata semplice, scandita in senso orizzontale da una cornice marcapiano e da due piccole paraste in senso verticale. Separato dal corpo principale del complesso vi è un enorme scariazzo, che si sviluppa per circa 200 metri, ed inoltre un edificio destinato a mungitoio, anch'esso di notevoli proporzioni, che conserva ancora al suo interno gli antichi sistemi di mungitura delle pecore. La masseria rappresenta un importante esempio di azienda agropastorale nota con il nome di "posta", in passato molto diffusa nel Tavoliere, in stretta correlazione con la pastorizia transumante che si sviluppava attraverso percorsi interregionali che interessavano l'Abruzzo, il Molise e la Puglia settentrionale; la struttura costituiva, dunque, una dimora temporanea per i pastori che riconducevano le greggi verso la pianura nel periodo autunnale ed invernale. In questo caso, tuttavia, alla funzione prettamente pastorale si aggiunse l'attività agricola, favorita anche dalla posizione particolarmente favorevole, che determinò pertanto l'occupazione stabile della struttura.
Definizione Ambito Culturale:
- Dato non disponibile
- Zaccaria C., Le masserie: aspetto storico e tipologico. Analisi di organismi edilizi campione nell'area di Capitanata, Borri D., Contributo allo studio del paesaggio urbano e rurale in età moderna: le masserie in Puglia, , : Enaudi, 1983
- Mongiello L., Masserie di Puglia. Organismi architettonici ed ambiente territoriale, Masserie di Puglia. Organismi architettonici ed ambiente territoriale, , Bari: , 1996
Scheda
- FGBIS001394
Tipologia del bene
Tipo: Masseria
Funzione:
- Produttiva/lavorazione/artigianale
- Abitativa/residenziale
- Agricola
Condizione Giuridica
Proprietà privata
-
Tipo: Soprintendenze ambito architettura-belle arti-paesaggio
Ente: SABAP-FG (Archite-BA-Pae)
Ruolo: Tutela e valorizzazione
-
elemento contenuto in - Sito Pluristratificato
Periodo:
- Età contemporanea (XIX-XXI secolo)
Motivazione:
- Bibliografia
- Documentazione
- Integro
- Restaurato
Criterio di perimetrazione: Perimetrazione effettuata su base ortofotografica
Tipo Fruibilità: Struttura ricettiva
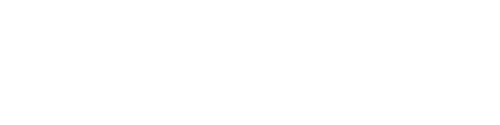








.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)