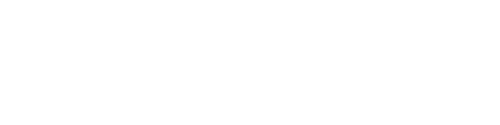Esplora la Carta
La struttura è composta da un nucleo più antico tardo quattrocentesco, di forma quadrangolare che si articola intorno ad un cortile centrale. L’aspetto tardo quattrocentesco permane nella facciata principale che prospetta su Piazza del Popolo, le cui impostazione dall’andamento dinamico e articolato è conclusa in alto da un lungo coronamento a beccatelli parzialmente conservato e da una parte aggiornata in epoca barocca. Al centro è l’arco di ingresso al palazzo, oggi sormontato dall’emblema dei marchesi Ferrante. Frutto di diversi interventi che nel tempo hanno modificato l’originaria fisionomia castellana, la residenza conserva l’assetto e l’impianto tipologico e distributivo conferitole nella prima metà del Seicento dalla famiglia Brancaccio. Gli interventi realizzati tra il 1626 e il 1654 interessano soprattutto i volumi interni e lo splendido cortile. A Rinaldo, capostipite della famiglia napoletana dei Brancaccio, viene tradizionalmente attribuita la ridefinizione delle strutture fortificate preesistenti nelle forme attuali di palazzo. Al nipote Carlo viene attribuita la volumetria esterna e parte della decorazione interna, soprattutto con l’apparato decorativo e scultoreo del cortile. Superato l’androne di ingresso con volta cordonata, si accede in uno splendido cortile organizzato su due ordini di arcate inquadrate da lesene lisce al piano terra, scanalate al piano superiore. Il cortile è impreziosito da una ricca ornamentazione “all’antica” che riveste gli estradossi degli archi e i pilastrini della balaustra con elmi, scudi, corazze, faretre e armi da fuoco, mentre nel loggiato superiore, lungo le pareti, corre un fregio affrescato con scene di soggetto mitologico tratte dalle Metamorfosi di Ovidio (Giove e Antiope, il Ratto di Europa, Pyramo e Tisbe, il Giudizio di Paride). In una nicchia a giorno posta tra le arcate della loggia è collocata la statua del capostipite Rinaldo Brancaccio, in asse con i presunti ritratti, entro tondi, del figlio Ferdinando e del nipote Carlo. Sulla trabeazione superiore, una memoria epigrafica entro uno scudo ovale reca il nome dell’artefice e la data “M[ASTRO] ANGELO RICCIARDO / DI LECCE SCOLPIVA / 1654”. All’appartamento nobile si accede da uno scalone collocato a destra dell’ingresso, sul lato orientale del cortile, che conduce ad un monumentale ingresso con arco “a spezzata”, oggi sormontato dallo stemma dei Leuzzi. Da qui si accede a vari saloni di rappresentanza e alle camere e alloggi personali. All’interno è presente una Sala del Consiglio (o “Galleria”), affacciata sul cortile sul lato orientale, ripristinata da Rinaldo, con affreschi le cui scene illustrano episodi tratti dalla Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso. Tra Sei e Settecento il palazzo subisce una radicale trasformazione anche sul versante occidentale, con l’edificazione di una lunga balconata ad avancorpo che prospetta su Piazza San Francesco. L’avancorpo è ornato da una teoria di undici arcate con paraste a bugne e coronato da una balaustra a pilastrini, che gira anche su Piazzetta Ruffo fino alla medievale Torre delle Moline. La struttura è conosciuta come “Porticato dei Mercatanti” in quanto le arcate inquadravano gli ingressi di opifici, manifatture e botteghe. In corrispondenza delle ultime due arcate a sud un lungo ambiente era destinato a palmento, collegato alla Torre delle Moline. Questo lungo corpo terrazzato viene realizzato dai D’Amore per collegare il castello alla contigua Porta Vecchia, ma saranno i loro successori, i Ferrante, ad apporre sia sul portale d’ingresso che prospetta su Piazza del Popolo che sulla Porta Vecchia il proprio stemma.
Definizione Ambito Culturale:
- Dato non disponibile
- Cazzato M., Lecce e il Salento 1, Atlante del Barocco in Italia, , Roma: De Luca Editori d'Arte, 2015
- De Lorentis D., Basile V. a cura di, Il feudo di Ruffano dai Brancaccio ai Ferrante: ristrutturazione della roccaforte e politiche di rinnovamento urbano tra Sei e Settecento, Dal castello al palazzo baronale. Residenze nobiliari nel Salento dal XVI al XVIII secolo, , Galatina: , 2008
- De Lorentis D., Fagiolo M. a cura di, Una corte a misura di principe: il feudo di Ruffano dai Brancaccio ai Ferrante, Atlante tematico del Barocco in Italia. Il sistema delle residenze nobiliari. Italia Meridionale, , Roma: , 2010
- De Lorentis D., De Filippis M. a cura di, La terra e il castello di Ruffano, Messapia. Forme del territorio e delle città del Salento meridionale, , Bari: , 2013
- Pizzolante Leuzzi F., Pizzolante Leuzzi F. a cura di, Caratteri stilistici del castello di Ruffano in provincia di Lecce, Caratteri stilistici del castello di Ruffano in provincia di Lecce, , Ruffano: , 2002
- De Bernart A., L'antico assetto urbanistico di Ruffano e la chiesa di San Marco, L'Antico assetto urbanistico di Ruffano e la chiesa di San Marco, , Ruffano: , 1996
Scheda
- LEBIU002156
Tipologia del bene
Tipo: Palazzo
Funzione:
- Difensiva/militare
- Abitativa/residenziale
Condizione Giuridica
Proprietà privata
-
Tipo: Soprintendenze ambito architettura-belle arti-paesaggio
Ente: SABAP-LE (Archite-BA-Pae)
Ruolo: Tutela e valorizzazione
-
elemento contenuto in - Complesso Topografico
Castello Brancaccio (età medievale, moderna e contemporanea) - LEBIC000130
Periodo:
- Basso Medioevo (XI-XV secolo)
- Età contemporanea (XIX-XXI secolo)
- Età moderna (XVI -XVIII secolo)
Motivazione:
- Analisi delle strutture
- Bibliografia
- Integro
Criterio di perimetrazione: Si perimetra l'area occupata dalle strutture.
Tipo Fruibilità: Non fruibile