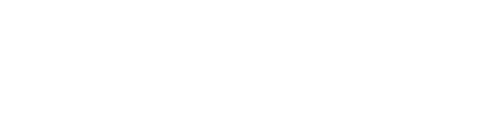Esplora la Carta
La chiesa rupestre di San Vito alle Fornaci (detta anche San Vito Vecchio), abbandonata nel corso dell'età moderna, insieme a quelle del comprensorio, per l'estrazione di tufo dalle cave vicine, impiegata prima come cisterna e poi come deposito, è oggi collocata all'interno di un giardino privato. La parete di ingresso è modulata da un grande portale ad arco a sesto pieno, accompagnato da due arcate cieche ai lati nelle quali sono state aperte successivamente due feritoie, al pari della finestra tarda e non originaria, tagliata a forza nel tufo sopra la cornice del portale principale. L'interno, realizzato secondo un accurato processo di escavazione e levigazione delle superfici, presenta una pianta rettangolare molto regolare, coperta da volte a botte e conclusa da un catino absidale sul fondo. Il ciclo di affreschi che decorava la piccola chiesa rupestre, interamente staccato nel 1956, restaurato e ricomposto nel Museo presso la Fondazione "E. Pomarici Santomasi", rappresenta un indiscusso vertice qualitativo della pittura pugliese del maturo XIII secolo, e un episodio rilevante anche in ragione del suo stato di conservazione decisamente eccellente rispetto al panorama pittorico rupestre sia pugliese sia lucano. La chiesa, le cui superfici originarie sono state riprodotte in modo quasi palmare nel nuovo ambiente museale, è interessata da un decoro pittorico che ricopre la maggior parte della superficie rupestre, distribuito tra le due pareti laterali e il catino absidale. Quest'ultimo è occupato da un monumentale Cristo Pantocratore (cioè benedicente) in maestà, seduto su un imponente trono provvisto di cuscino mentre sostiene il Libro Sacro con la mano sinistra ed è circondato da una mandorla sorretta da quattro angeli. La cornice dell'archivolto che avvolge a nastro il bordo del catino è decorata da un motivo a zigzag. Le pareti sono entrambe abitate da due teorie continue di santi sotto arcatelle, per la maggior parte riconoscibili sia per gli attributi iconografici sia per le iscrizioni esegetiche. Solo sulla parete sinistra, dopo la teoria di quattro santi - San Pietro, San Lazzaro, San Giacomo, San Basilio - segue una scena isolata tratta dal Nuovo Testamento: le Mirrofore al sepolcro vuoto di Cristo. L'episodio, di largo successo nei programmi iconografici tradizionali bizantini, rappresenta l'unica scena narrativa superstite dell'intero. Sulla parete destra, la teoria di santi è avviata da Santa Caterina che accompagna una imponente Vergine Theotokos in trono, seguita da San Bartolomeo, San Nicola, Santa Margherita e San Cosma, forse seguito da San Damiano, non riconoscibile.
Definizione Ambito Culturale:
- Dato non disponibile
- Navedoro G., Le chiese rupestri di Gravina in Puglia. Considerazioni prliminari su alcuni ambienti conosciuti o ancora inediti : Il Grillo Editore, 2006
- Dell'Aquila F., Messina A., Le chiese rupestri di Puglia e Basilicata : Adda Editore, 1998
- Falla Castelfranchi M., La pittura monumentale bizantina in Puglia, ,1991
- Belli D'Elia P., La Puglia tra Bisanzio e l'Occidente, Civiltà e Culture in Puglia, 2, Milano: ELECTA, 1980
- Domenico Nardone, Notizie storiche sulla città di Gravina: dalle origini all'unità italiana 455-1870, Volume unico, , Bari: Adda Editore, 2003
- Giordano, D., Il comprensorio rupestre appuro-lucano: casali e chiesi da Gravina al Bradano, Il comprensorio rupestre appuro-lucano: casali e chiesi da Gravina al Bradano, , Bari: Levante Editore, 1992
Scheda
- BABIU002199
Tipologia del bene
Tipo: Luogo di culto rupestre
Funzione:
- Sacra/religiosa/culto
Condizione Giuridica
Dato non disponibile
-
Tipo: Soprintendenze ambito archeologico
Ente: Sop. Archeologia Puglia
Ruolo: Tutela e valorizzazione
-
Bene composto [è riutilizzato da] - Sito
-
Relazione urbanistico ambientale [è in relazione urbanistico ambientale con] - Sito
-
elemento contenuto in - Sito
Periodo:
- Basso Medioevo (XI-XV secolo)
- Alto Medioevo (VII-X secolo)
Motivazione:
- Analisi delle strutture
- Analisi stilistica
- Bibliografia
- Conservato parzialmente
- Ricostruito
Criterio di perimetrazione: si perimetra l'area occupata dalla chiesa rupestre