Esplora la Carta
L'anfiteatro di Lecce, della tipologia "a struttura vuota", presenta una dimensione massima di 101,88 x 83 m, con l'asse maggiore orientato in senso est-ovest, mentre l'arena è di 53,08 x 34,20 m; la cavea ha uno spessore di 24,50 m. La struttura sfrutta il banco naturale di pietra leccese come supporto e parte integrante del sistema di sostegno della cavea, con il vantaggio di un risparmio di materiale lapideo nella costruzione delle fondazioni. Dall'analisi del monumento, il livello del piano base dell'anfiteatro corrisponde alla quota di spiccato dei pilastri esterni e, dunque, al piano di camminamento del relativo portico perimetrale. Tale livello era preesistente alla costruzione dell'edificio e conforme alla quota del tessuto urbano e della viabilità cittadina. Nel progetto edilizio del monumento il grande ambulacro inferiore, mediamente fino all'imposta della volta, parte del muro anteriore del podium, delle gallerie radiali di raccordo e il cunicolo circumpodiale, sono stati ottenuti attraverso la lavorazione del banco roccioso ricavandone blocchi utilizzati nell'ambito del cantiere stesso. La disomogeneità del piano di roccia lungo il portico perimetrale dell'edificio è stata risolta mediante una diversa lavorazione delle basi dei pilastri variandone l'altezza tra 35 e 70 cm. La scelta di utilizzare al massimo il banco originario, ha costituito una soluzione vantaggiosa dal punto di vista sia pratico che economico, ma che tuttavia ha condizionato di conseguenza un rilevante dislivello, di circa 3,50 m, tra il piano di calpestio esterno e quello dell'arena. L'ingresso principale, posto in corrispondenza dell'asse maggiore sul lato ovest, misura 6,20 m di larghezza ed è anch'esso in parte scavato nella roccia di base e in parte costruito con grandi blocchi squadrati su cui si imposta la volta in cementizio. La stessa soluzione costruttiva è stata adottata per l'ingresso posto sul lato settentrionale dell'asse minore, che presenta una larghezza di 5,70 m. Nella progettazione dell'edificio si è previsto uno scheletro portante articolato su tre ellissi concentriche. Tale sistema è costituito dai due ordini di pilastri che formano il portico esterno collegati dagli archi in conci sui due livelli della cavea e dal muro continuo su cui si attestano i setti murari radiali dei fornici ciechi al piano terra; quest'ultima struttura, doveva proseguire al livello superiore come contenimento dei riempimenti per le scale che conducevano alla media cavea. Dell'edificio,sono in opera quadrata, oltre ai pilastri del portico esterno i muri perimetrali degli ingressi principali che evidenziano come il progetto costruttivo dell'anfiteatro sia stato concepito in quattro settori distinti, organizzati specularmente secondo l'asse minore. Sei passaggi, posti in asse con altrettanti accessi dall'esterno, permettevano la comunicazione tra l'ambulacro inferiore e l'arena. Questi, accessibili solo al personale di servizio, sono scavati in maniera equidistante nel banco roccioso e presentano pareti irregolari grossolanamente lavorate. Da questi passaggi era inoltre possibile accedere, per la manutenzione e la pulizia, allo stretto cunicolo circumpodiale posto alle spalle del muro del podium, che collegato ad un pozzo-cisterna ubicato al centro dell'arena era funzionale al drenaggio delle acque piovane. L'analisi del complesso monumentale permette di indicare un progetto unitario nella realizzazione delle strutture relative alla cavea; la datazione dell'anfiteatro, ancora non risolta definitivamente in modo assoluto, è suggerita dalle caratteristiche tecniche e dai caratteri formali di alcuni elementi architettonici. Allo stato attuale della ricerca la cronologia accettata propende all'età augustea e giulio-claudia per la realizzazione complessiva dell'edificio con interventi successivi databili al corso del II sec. d.C., fase in cui viene aggiunto il portico in summa cavea, a cui potrebbero riferirsi alcuni blocchi di marmo rinvenuti nello scavo. La decorazione architettonica dell'impianto originario, particolarmente sobria, è limitata alle lesene con basi e capitelli semplici, poste sui pilastri esterni, e alla cornice che scandiva la divisione formale tra I e II piano. La lavorazione della faccia vista dei blocchi si presenta piuttosto corsiva, con poca cura nelle rifiniture e nell'omogeneità delle superfici lapidee in cui è assente anche un rivestimento parietale. All'età augustea e giulio-claudia appartengono anche i rilievi in marmo pentelico con scene di venationes che decoravano il balteus. Il fregio, che presenta un profilo semicircolare coronato superiormente da un listello aggettante, doveva originariamente svolgersi sull'intero perimetro del podium lungo complessivamente 140,50 m. I 56 elementi rinvenuti, tra blocchi e frammenti, presentano lunghezze variabili per uno sviluppo totale di 70,25 m, pari al 50% dell'intero ciclo. I blocchi del fregio erano originariamente imperniati sulla faccia superiore del balteus e collegati attraverso una risega, posta lungo il margine anteriore del piano di posa, alle lastre di marmo che rivestivano il muro del podium, su cui si leggono ancora i numerosi incassi relativi alle grappe di sostegno. Il repertorio decorativo e la sintassi compositiva vede contrapposte figure di animali (tori, orsi, cinghiali, lepri, cani, cervi, zebre, pantere, leoni ed elefanti) a venatores e bestiarii armati in cui si alternano scene di caccia e di lotta tra le fiere, costituendo un caso piuttosto isolato tra i complessi decorativi posti a coronamento del muro del podium, generalmente privo di qualsiasi ornamento. Le figure si stagliano su un fondo neutro, privo di elementi paesaggistici, che contrasta con il decorativismo profuso nella resa naturalistica e nei particolari anatomici delle figure umane e animali. Ad età medio-imperiale (II sec. d.C.) sono attribuibili, invece, alcuni capitelli corinzieggianti a calice, un capitello corinzio figurato con testine femminili e alcune basi modanate in marmo, rinvenuti nello scavo dell'arena e delle gallerie e successivamente dispersi o reimpiegati in altre strutture. Dallo scavo dell'anfiteatro provengono inoltre alcune sculture in marmo a tutto tondo, databili ad età augustea e giulio-claudia, probabilmente riferibili all'apparato decorativo di un edificio circostante e attualmente conservate presso il Museo Sigismondo Castromediano. Tra gli esemplari più interessanti si annoverano una testa maschile in cui è possibile riconoscere il ritratto di Augusto, e una statua di Athena, copia romana di un tipo elaborato alla fine del V sec. a.C. Ad età antonina si riferisce invece una testa maschile barbata in marmo, in cui i caratteri fisiognomici si possono confrontare con i ritratti attribuiti a Lucio Vero (fotografie su concessione del MiBACT – Direzione Regionale Musei Puglia - MIBACT_PM-PUG 11/06/2020 0002436-P 28.10.13/11.4/2019).
Notizie storico-critiche:
- Alcuni studiosi ipotizzano che l'anfiteatro possa essere stato fortificato, secondo quel fenomeno conosciuto come "incastellamento degli anfiteatri romani"; in età bizantina e normanna.
- L’anfiteatro romano di Lecce fu messo in luce per la prima volta tra il 1901 e il 1910da Cosimo de Giorgi che effettuò una campagna di scavo in occasione della costruzione della Banca d’Italia. Già precedentemente, già nel Cinquecento, a quanto riporta il Galateo, era possibile accedere ad ambienti sotterranei che furono via via interpretati erroneamente, ma in ogni caso definiti come tracce della città romana. Ai primi del Novecento si procedette con lo scavo di una piccola parte della struttura, proprio davanti alla neo costruita Banca d’Italia. L’aspetto della piazza cambiò radicalmente in età fascista quando si decise di scavare l’anfiteatro distruggendo i palazzi che vi erano sopra e spostando la colonna di Sant’Oronzo.
Definizione Ambito Culturale:
- Età traianeo-adrianea
- Bernardini, M., Lupiae, Lupiae, Lecce, 1959
- Giardino L., D'Andria F. a cura di, L'impianto urbano, Lecce romana e il suo teatro, , Galatina: Congedo Editore, 1999, 83-93
- De Mitri C., Inanissima pars Italiae. Dinamiche insediative nella penisola salentina in età romana, ,2010
- D'Andria F., De Stefano M. a cura di, Una nuova "lettura" di Lecce; il contributo delle recenti ricerche, Lecce. Riqualificazione e valorizzazione ambientale, architettonica e archeologica del centro storico, , Roma: De Luca Editori d'Arte, 2004, 58-59
- Corchia, R., Rilievi con venationes dall'anfiteatro di Lecce: problemi e proposte di lettura, Studi di Antichità, , Galatina: Congedo Editore, 1980, 117-142
- Delli Ponti G., Edizione archeologica della carta d'Italia al 100.000, P 204 (Lecce), Edizione archeologica della carta d'Italia al 100.000, P 204 (Lecce), , Firenze: , 1968
- Pensabene P., Pensabene P. a cura di, Un'officina greca per gli elementi decorativi dell'anfiteatro di Lecce, Ricerche e Studi, VI, Brindisi: , 1972, 9-38
- Semeraro G., D'Andria F. a cura di, Arte e artigianato nella Lecce romana, Lecce romana e il suo teatro, , Galatina: Congedo Editore, 1999, 105-115
- Arthur P., Dieci anni di archeologia al castello di Lecce, Il castello Carlo V. Tracce, memorie, protagonisti, , Galatina: Congedo Editore, 2014, 29-35
- Amici C. M., AA. VV. a cura di, Iter progettuale e problemi architettonici dell’anfiteatro di Lecce, Metodologie di catalogazione dei beni archeologici, BACT 1.2, , Bari: , 1997, 181-198
- Amici C. M., D'Andria F. a cura di, L'Anfiteatro romano, Lecce romana e il suo teatro, , Galatina: Congedo Editore, 1999, 95-103
Scheda
- LEBIU000235
Tipologia del bene
Tipo: Anfiteatro
Funzione:
- Pubblica
Condizione Giuridica
Proprietà Stato
-
Tipo: Soprintendenze ambito archeologico
Ente: Sop. Archeologia Puglia
Ruolo: Tutela e valorizzazione
-
elemento contenuto in - Sito
Periodo:
- Età tardoantica (IV -VI sec. d.C.)
- Età romano imperiale (I-III sec. d.C.)
Motivazione:
- Analisi delle strutture
- Bibliografia
- Conservato parzialmente
Tipo Fruibilità: Area archeologica
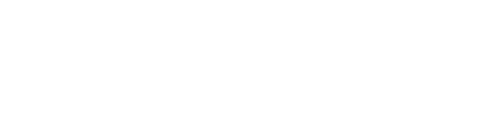








.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)