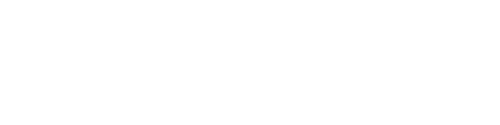Esplora la Carta
Il castello di Grottaglie, che ha costituito una delle sedi dell’arcivescovato di Taranto, è ubicato nella settore sudorientale del centro storico di Grottaglie, a ridosso del Quartiere delle Ceramiche, in posizione dominante su quella che era la gravina di San Giorgio; questa incisione carsica, attualmente urbanizzata e il cui andamento è ripreso dall’attuale via Crispi, corrisponde molto probabilmente al nucleo più antico dell’abitato medievale di Grottaglie. Nella sua configurazione attuale il castello si presenta composto da due blocchi; quello principale, disposto a sudest, è articolato intorno ad un atrio ed è circondato da mura sul lati nord ed est, mentre sui lati sud e ovest i bastioni coincidono con il fabbricato principale. Il settore a nordovest, di più recente edificazione, è edificato solo sul lato ovest ed è occupato per la maggior parte della sua estensione da un vasto cortile/giardino interno, delimitato da mura in età contemporanea. Il complesso così definito ha la pianta grosso modo di un trapezio, orientato in senso NW/SE, con la base rivolta ad ovest e ingresso sullo stesso lato. Tra i due cortili attorno a cui si articolano i due blocchi del complesso si erge la torre maestra, che fa parte del nucleo originario del castello. All’angolo sud-est, nel punto di giunzione tra il fabbricato e la cinta, si trova una torre di cortina pentagonale, prospiciente il "Quartiere delle Ceramiche". Adiacente al lato ovest del castello, e ad esso collegato tramite scalinate, è il giardino fatto realizzare nel XVII secolo dal cardinale Bonifacio Caetani. Il fabbricato principale, nel quale aveva sede l'episcopio, si sviluppa su due piani con un parziale terzo livello nell'ala di sud-est; la torre interna invece presenta quattro piani oltre il lastrico tutti indipendenti tra loro e collegati con l'esterno mediante un sistema di scale esterne attualmente diruto. Il nucleo principale del castello fu fatto costruire nel 1388 dall’arcivescovo Giacomo D’Atri, il quale promosse anche la realizzazione della Collegiata di Grottaglie e l’edificazione delle mura cittadine; è possibile però che quella promossa dall’arcivescovo fosse, più che una costruzione ex – novo, la riedificazione di una struttura preesistente. Dall’analisi della planimetria del complesso si può dedurre che una prima cinta fortificata, identificabile con quella che chiude l’atrio meridionale (provvista forse di una seconda torre di cortina, successivamente distrutta) esistesse già prima del 1388. Un indizio in tal senso è costituito dalle tracce di una porta in stile gotico, poi occlusa, visibili nel muro che divide i due cortili (e che corrisponde al muro settentrionale del nucleo originario del castello). La esistenza di tale porta potrebbe anche giustificare la localizzazione della torre maestra e tutto il sistema degli accessi ai livelli superiori della stessa: sistema che doveva servire anche per la coeva parte di primo piano del fabbricato principale, corrispondente alla zona della sala episcopale. In ogni caso la prima configurazione conclusa del castello (quella dovuta a Giacomo D’Atri) doveva essere costituita dalle mura, dalla torre maestra interna, dalle sale di primo piano destinate a dimora dell'arcivescovo, e da due torri di cortina rispettivamente a sud-est e sud-ovest. Nella seconda metà del XV secolo il primitivo impianto venne ampliato comprendendovi il cortile nordoccidentale ed una ulteriore torre di cortina posta a difesa della porta per l'abitato, attualmente trasformata in fornice aperto. È possibile che questo settore settentrionale sia stato edificato nel 1483 quando, secondo un documento della Curia di Taranto (citato dal Blandamura, vedi bibliografia), il cardinale arcivescovo Giovanni d’Aragona procedette alla ricostruzione di parte delle fortificazioni cittadine, vietando che una parte di materiali costruttivi fosse dirottata verso Taranto per analoghi lavori. Un ulteriore importante intervento fu effettuato tra il 1613 ed il 1617, quando, per volere del cardinale Bonifacio Caetani, il castello fu trasformato in una dimora aristocratica, con l’edificazione di ulteriori stanze al piano nobile; nello stesso periodo fu realizzato il vasto giardino esterno, che venne dotato di recinzione e ingresso monumentale. Nel 1649 l’edificio fu oggetto d’interventi promossi dal mons. Tommaso Caracciolo, consistenti nella costruzione di una cappella e nella realizzazione sia dei disimpegni per le sale esistenti che del loggiato interno, che fu collegato all’atrio da uno scalone oggi non più esistente. Nel XX secolo il castello subisce le ultime modifiche strutturali, con l’innalzamento del piano di calpestio nel cortile nordoccidentale e la conseguente costruzione della intercapedine per mantenere illuminati i locali interni (che prima di tale modifica erano aperti sul piano di calpestio); la costruzione di corpi aggiunti al piano terra ed al primo piano, ove hanno trovato posto gli impianti igienico-sanitari connessi all'attuale destinazione del castello (che è quella di convitto) ed, in genere, i lavori di riattamento delle sale interne. Fino a tempi recenti il castello è stato proprietà dell’Arcivescovato di Taranto, che lo ha poi ceduto al Comune di Grottaglie. Gli spazi del castello anticamente adibiti a stalle, localizzati nel settore SE, ospitano oggi le sale del Museo della Ceramica, che in estate utilizza il giardino come sede espositiva dell’annuale Mostra della Ceramica mediterranea; solo in questo periodo (agosto-settembre) il giardino Giacomo D’Atri è aperto al pubblico.
Notizie storico-critiche:
- Nel XX secolo il castello subisce le ultime modifiche strutturali, con l’innalzamento del piano di calpestio nel cortile nordoccidentale e la conseguente costruzione della intercapedine per mantenere illuminati i locali interni; la costruzione di corpi aggiunti al piano terra ed al primo piano, ove hanno trovato posto gli impianti igienico-sanitari connessi all'attuale destinazione del castello (che è quella di convitto) ed, in genere, i lavori di riattamento delle sale interne.
- Nel 1649 l’edificio fu oggetto d’interventi promossi dal mons. Tommaso Caracciolo, consistenti nella costruzione di una cappella e nella realizzazione sia dei disimpegni per le sale esistenti che del loggiato interno.
- Tra il 1613 ed il 1617, per volere del cardinale Bonifacio Caetani, il castello fu trasformato in una dimora aristocratica; viene rifatta la facciata e vengono realizzate le stanza del piano nobile.
- Verosimilmente nella seconda metà del XV secolo al complesso medievale fu aggiunto il settore nordoccidentale del castello, con il suo ampio cortile.
- Nel 1388 viene costruito il nucleo principale del Castello per volontà dall’arcivescovo Giacomo D’Atri, in concomitanza con la costruzione delle mura cittadine
- AA. VV., Cazzato M. a cura di, Atlante del Barocco in Italia: Lecce ed il Salento, Atlante del Barocco in Italia: Lecce ed il Salento, , Roma: , 2015
- AA. VV., De Vita R. a cura di, Castelli e Torri della Terra d’Otranto, Castelli e Torri della Terra d’Otranto, , Bari: Adda Editore, 1975
- Blandamura G., La Baronia Arcivescovile e il Castello-Episcopio di Grottaglie, La Baronia Arcivescovile e il Castello-Episcopio di Grottaglie,, , Taranto: , 1933
- Claveri, N., Fagiolo M. a cura di, Il palazzo ducale e il castello – episcopio di Grottaglie: trasformazioni architettoniche e contese feudali, Il sistema delle residenze nobiliari. Italia Meridionale, , Roma: , 2010
Scheda
- TABIC000047
Tipologia del bene
Tipo: Castello (ambito urbano)
Criterio Identificazione: Dati bibliografici
Funzione:
- Abitativa/residenziale
- Difensiva/militare
Proprietario: Amministrazione dello Stato
Condizione Giuridica
Proprietà Ente pubblico territoriale
-
Tipo: Soprintendenze ambito architettura-belle arti-paesaggio
Ente: SABAP-LE (Archite-BA-Pae)
Ruolo: Tutela
-
elemento contenuto in - Sito
Periodo:
- Basso Medioevo (XI-XV secolo)
- Età moderna (XVI -XVIII secolo)
- Età contemporanea (XIX-XXI secolo)
Motivazione:
- Bibliografia
Cronologia specifica:
Dal: XIV d.C. Al: XXI d.C.
- Integro
Criterio di perimetrazione: Il bene è stato perimetrato sulla base dell'ortofoto