Esplora la Carta
La Pinacoteca “Michele de Napoli” nasce dal lascito testamentario con cui l’artista, nel 1892, volle donare al Comune di Terlizzi la ricca collezione delle sue opere, oltre mille tra dipinti e disegni, da collocarsi all’interno del palazzo in cui era vissuto. Inaugurata per la prima volta nel 1898, la Pinacoteca subisce a partire dagli anni ’60 del secolo scorso pesanti interventi di ristrutturazione che ne danneggiano la leggibilità nel suo complesso, con la dispersione di arredi e altri cimeli. Nel 2009 l’edificio, dopo lunghi e articolati lavori di restauro e rifunzionalizzazione, è stato restituito alla pubblica fruizione, con l’allestimento nel luglio 2010 della mostra “Michele de Napoli: dalla ‘pittura istorica’ alle opere tarde”, una selezione di 85 opere che abbraccia quasi sessanta anni di attività del pittore, condotta tra Napoli, Roma e la sua Terlizzi. La Pinacoteca, oltre a mostrare l’espressione creativa di Michele de Napoli, offre occasioni di approfondimento culturale attraverso l’organizzazione di mostre temporanee, attività e laboratori didattici rivolti ai bambini in età scolare. Dal 2018 la Pinacoteca è inserita nel circuito nazionale “Case della Memoria” che riunisce le case (oggi case-museo) dove vissero personaggi illustri in ogni campo del sapere, dell'arte, della letteratura, della scienza, della storia. Il Palazzo de Napoli, casa dell'autore in cui si colloca la Pinacoteca, è situato in Corso Dante 9 a Terlizzi. Tipica dimora settecentesca, consta di tre livelli più un seminterrato adibito a lapidario, dove sono conservati importanti reperti dell’antica Terlizzi, tra cui i resti del portale della distrutta cattedrale medievale. All’ingresso del palazzo, un androne con ampio scalone conduce al piano nobile che, con le sue VII sale espositive, accoglie la mostra permanente del pittore; si prosegue al piano superiore dov’è la direzione per poi giungere al piano terzo, dove sono collocati un’ampia e attrezzata sala seminari e la cosiddetta “sala blu” adibita ad ospitare mostre temporanee. Le 85 opere esposte nella Pinacoteca, particolarmente significative della ricerca artistica condotta da Michele de Napoli, vanno dagli anni ’30 dell’Ottocento fino agli ultimi anni della produzione dell’autore, poco prima della sua morte. I dipinti presenti nella I sala documentano l’attività nei primi anni della sua formazione avvenuta presso l’Istituto di Belle Arti di Napoli, al quale si iscrive nel 1833 dopo gli studi giuridici, influenzata soprattutto dalla lezione neoclassicista di Costanzo Angelini, che ne riconosce il valore e il temperamento al punto da indicarlo “leone dell’Accademia”. Tra i dipinti noti Mario e il Cimbro, ispirato, come altri, ad un episodio della storia antica e caratterizzato da una robustezza disegnativa tutta neoclassica, al quale fa da pendant Mario sulle rovine di Cartagine; Alessandro e il suo medico Filippo, bozzetto per il dipinto ammesso nel 1837 all’Esposizione di Napoli; Prometeo che plasma l’uomo con l’argilla, uno dei tanti studi per il dipinto che, conservato nel Museo di Capodimonte a Napoli, permise all’autore di vincere la medaglia d’oro in occasione dell’Esposizione di Napoli del 1841. Nella II sala sono conservati alcuni esempi di committenza pubblica, sia religiosa che civile, con dipinti di soggetto sacro, mitologico e storico. A quest’ultimo appartengono le tre opere di soggetto medievale, legate alla progettazione e realizzazione, nel 1854, del sipario per il teatro Piccinni a Bari: al primo soggetto, la Disfida di Barletta, leggibile anche come manifesto politico risorgimentale, si affiancano due versioni del Torneo di re Manfredi, tema meno impegnativo sul piano ideologico e prescelto per la definitiva realizzazione del sipario del teatro barese. Di soggetto sacro, l’Incredulità di san Tommaso, motivo ripreso negli studi per il Cristo e gli Apostoli realizzati per la decorazione del cimitero di Napoli e il bozzetto raffigurante San Francesco d’Assisi. Di intensa carica espressiva anche i ritratti qui conservati, un ritratto di uomo non identificato, quello della moglie Luisa Patella (1829-1891) e il potente Autoritratto, tutti accomunati dalla scelta di delineare con semplici tratti i busti per concentrare sui volti tutta la perizia pittorica dell’artista. Nella sala III sono esposte opere relative principalmente alla produzione degli anni '50 e '60 dell’Ottocento, periodo in cui de Napoli è impegnato in rilevanti iniziative di committenza ecclesiastica, come gli affreschi della chiesa di S. Domenico Maggiore a Napoli (1853-1854) e del Duomo di Capua (1855-1856). Altro tema avviato già negli anni Cinquanta e concretizzatosi nel 1885 con la grande pala per la Cattedrale di Terlizzi è quello del Ritorno dal Sepolcro: sono qui esposti alcuni studi, databili probabilmente a periodi diversi e nei quali si legge il lavorìo continuo nel corso degli anni prodotto dall’artista sul medesimo tema iconografico. Ancora di soggetto religioso la quasi totalità delle opere contenute nella Sala IV, tra cui il bozzetto per il dipinto, mai realizzato, raffigurante San Vincenzo Ferreri che dona i suoi averi ai poveri, destinato alla cappella privata della famiglia dell’artista in S. Maria La Nova a Terlizzi; al piano 3°, fuori mostra, è esposto un altro bozzetto di grandi dimensioni su questo soggetto, un carboncino su tela, che raffigura tra gli astanti lo stesso autore. Al tema del S. Francesco d’Assisi che mostra le stigmate sono dedicati un disegno di grandi dimensioni e due dipinti, tutti legati alla pala di analogo soggetto con cui de Napoli vinse la medaglia d’oro all’Esposizione di Napoli del 1851. Unico dipinto di tematica allegorica è il raffinato ritratto di tre fanciulle, importante testimonianza delle istanze di matrice neoclassica che informarono l’attività di de Napoli negli anni '30 e '40 dell’Ottocento, quando fu allievo a Napoli di Costanzo Angelini e poi durante il soggiorno romano (1839-1942). La sala V presenta una selezione di opere ascrivibili a vari ambiti tematici. Si ammirano alcune nature morte di estrema efficacia plastica, caratterizzate da grande equilibrio compositivo e da un attento studio degli effetti di luce sugli oggetti, tutti di uso quotidiano. Fa invece riferimento ad un episodio storico un disegno a carbone e gesso su carta, noto come Il colera a Ruvo, che ricorda l’epidemia che colpì la cittadina nel 1884. Le ultime due sale sono tutte dedicate ad opere realizzate per la Concattedrale di Terlizzi. Nella Sala VI vari studi per il dipinto della Maddalena penitente, realizzato nel 1884 per l’Esposizione Nazionale di Torino, dove però non fu esposto perché non accettato dal Comitato torinese, con grande dispiacere dell’autore. L’ultima sala accoglie dipinti e disegni dedicati alla grande pala raffigurante l’Invenzione della Madonna di Sovereto, tema caro ai terlizzesi, con bozzetti e studi preparatori, alcuni dei quali poi rigettati in fase di realizzazione finale dell’opera.
Tipologia prevalente: Museo, galleria non a scopo di lucro e/o raccolta
- Sito Web: https://pinacoteca.comune.terlizzi.ba.it/
- Email: pinacoteca@comune.terlizzi.ba.it
- Email Certificata: protocollo@pec.comune.terlizzi.ba.it
- Telefono: 080 3517577
Scheda
- BALDC000066
Condizione Giuridica: Detenzione Ente pubblico territoriale
-
Tipo: Soprintendenze ambito architettura-belle arti-paesaggio
Ente: SABAP-BA (Archite-BA-Pae)
Ruolo: Tutela
-
Tipo: Comune
Ente: Comune di Terlizzi
Ruolo: Tutela
-
Tipo: Comune
Ente: Comune di Terlizzi
Ruolo: Proprietario
-
Relazione urbanistico ambientale [è in relazione urbanistico ambientale con] - Sito
-
Tipo: Opuscoli
Denominazione: Illustrazione mostra temporanea
Modalità acquisizione: Commissionata dal Comune
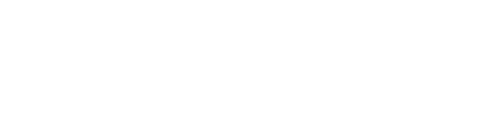








.JPG)
-min (1611007072).jpg)
-min (1611008004).jpg)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
-min (1610962159).jpg)
.jpg)
.jpg)