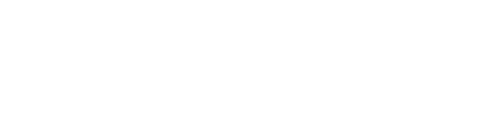Esplora la Carta
Manfredonia sorge a 5 m s.l.m, sull’omonimo golfo. La città prende il nome da Manfredi di Sicilia, figlio dell’Imperatore Federico II, perché fu costruita per suo volere per ospitare gli scampati alla distruzione di Siponto del 1223, e la sua fondazione risalirebbe dunque al ufficialmente al 1263, lasciando pochissimo tempo al re, (morto nel 1266) di mettere in pratica il suo progetto grandioso sia per quanto riguarda la città, che il porto, la cinta e il castello. Nel 1272 visitò Manfredonia fu visitata da papa Gregorio X ed in questa occasione Carlo dietro consiglio del papa fece collocare una lapide a Porta Puglia e ribattezzò la nuova città col nome di Sypontum Novellum o Sipontum Nova, denominazione che tuttavia non si affermò. Nel novembre 1277 troviamo le prime testimonianze della fortificazione della città, in una convenzione tra la Regia Curia angioina e mastro Giordano di Monte Sant’Angelo per la costruzione delle mura cittadine. La cinta ha andamento rettangolare sui tre lati di terra, mentre sul lato della costa segue la conformazione rocciosa. Con gli Aragonesi, le mura furono ulteriormente fortificate, con la realizzazione di torri circolari casamattate e un fossato. Dal castello, le torri sono denominate: torrione delle Capre, denominato poi dell'Astrologo, torrione di S. Maria, torrione di Gasparre (demolita ad inizio Novecento), torrione di S. Benedetto (demolita ad inizio Novecento), torrione de Angelis, torrione S. Francesco, torrione del Fico. Ad est le mura sono state distrutte per l’ampliarsi dell’abitato in età moderna, così come nella zona sul mare, a sud, dove le case sono state costruite addossate alle mura e inglobandole. Dal 1424 al 1435 diventa contea di Francesco Sforza. Nel 1463 fu saccheggiata da re Ferdinando, ma restò fedele alla corona aragonese e nel 1528 resistette all’attacco dei Francesi. Tra il 16 e il 18 agosto 1620 fu attaccata dai Turchi, pesantemente saccheggiata e in parte distrutta. L’imponente castello di Manfredonia nonostante sia spesso accreditato, perlomeno nel suo nucleo centrale, di conservare vestigia del periodo Svevo non sembra in realtà conservare tracce né in elevato, né a livello di impianto, del progetto svevo. Già Haseloff interpreta la grande mole di documenti, risalenti al periodo della costruzione di mura e castello, ritenendo che della fortificazione non restino tracce di impianto o elevato Svevo. Inoltre anche delle opere del periodo Angioino, rimarrebbe ben poca cosa, datando quindi, praticamente l’aspetto dell’intero complesso, ad epoca aragonese, con successivi ampliamenti (il puntone dell’Avanzata). Presenta una doppia cinta muraria. Quella esterna è caratterizzata da tre torri a pianta circolare e una a punta di freccia ad ovest, mentre di quella interna delle quattro che restano in pianta, tre risultano essere circolari, mentre l’unica a pianta quadrangolare sembra essere quella ad Est. In realtà anche il torrione Nord, poggia “su un basamento quadrangolare in conci di pietra squadrata di altezza di circa 60 centimetri”, presentando feritoie, alla stessa quota e dello stesso tipo di quelle della torre ad Est, poi verosimilmente modificate in epoca aragonese. Dopo la calata dei turchi nulla restò di Manfredi e dei d'Angiò, tranne la piccola Chiesa di San Marco con la volta lesionata, parte del Castello e le antiche mura. San Marco prese le funzioni di cattedrale fino alla costruzione del nuovo duomo nel 1640 dedicato a San Lorenzo Maiorano. L'Arcivescovo sipontino Annibale sceso dai monti del Gargano per constatare le rovine osservò che la valanga turca non aveva lasciato altro che rovine, desolazione, lutti e miserie. Questi, aiutato dal cardinale, viceré Borgia ottenne franchigie per trent'anni per i dispersi manfredoniani. Nel 1624 fu riedificato il Duomo e nel 1644 il nuovo Seminario. Grande aiuto alla ricostruzione fu dato dall'arcivescovo cardinale Orsini (poi papa Benedetto XIII), che resse la diocesi sipontina dal 1675 al 1680. Altre architetture religiose presenti all’interno della cinta muraria cittadina sono la Chiesa e Monastero di Santa Chiara fondato, secondo i documenti, il 21 novembre 1592 dalla nobildonna Isabella de Florio, chiesa distrutta dai turchi, ricostruita ad una sola navata e consacrata nel 1680 dal cardinale Orsini; Chiesa e Convento di San Benedetto; Chiesa e Convento di Santa Maria delle Grazie, chiesa di San Matteo, Chiesa e Convento di San Domenico, Chiesa e Convento di San Pietro dei Celestini, Chiesa e Convento di San Francesco, Chiesa e Convento dell’Umiltà. Sono presenti, inoltre, numerosi palazzi signorili di età moderna. Nel 1737, Manfredonia aveva una popolazione di 536 abitanti e nel 1749 di 3238. Alla pubblica istruzione provvedeva un solo maestro, la cui remunerazione ammontava a 12 ducati annui nel 1754. Nel 1783, per ordine dell'arcivescovo con una spesa di 200 ducati veniva trasferito il cimitero dal vecchio ubicato al centro della città attaccato alla Cattedrale all'attuale ubicazione attaccato alla chiesa di Santa Maria dell'Umiltà. La prima mappa della città di Manfredonia si ebbe sotto il Sindaco Giacinto Cipriano il 22 aprile 1787. Furono stabiliti i confini del territorio che toccavano l'antica Salpi estendendosi nella Puglia fino a Borgo Mezzanone, Ramatola con Santa Tecla, Farano, Ciminiera, Coppolachiatta, Colonnelle e sotto i monti del Gargano e verso Macchia (frazione del Comune di Monte Sant'Angelo). Nel 1835, veniva ultimata la strada Manfredonia-Foggia e avviata la comunicazione Manfredonia-Cerignola. In questo stesso anno furono lastricate molte strade interne di Manfredonia e aperta "alla ruota" la strada Manfredonia-Monte Sant'Angelo. Solo dopo gli inizi del XIX secolo, migliorate le vie di comunicazione e il porto, si creò una situazione favorevole al commercio e la città cominciò di nuovo ad espandersi e a crescere. Testimonianza di questo sviluppo è il dato di fatto che la città di Manfredonia fu anche sede nel settecento di un'importante magistratura speciale, il Tribunale del Consolato di Terra e di Mare, che trattava le vertenze inerenti al commercio marittimo ed estero. L’abitato contemporaneo si sviluppa verso sud, tanto da inglobare la frazione di Siponto, e verso nord, abbracciando il nucleo storico delimitato dalle antiche mura. L’abitato è delimitato a nord e nord-ovest dalla SS89, mentre a sud e sud-est dal mare ed è separato da Siponto da via Giuseppe di Vittorio.
- Haseloff A., Architettura sveva in Italia meridionale, 1992
- Russo S., Russo S. a cura di, Storia di Manfredonia. II. L'età moderna, L'età Moderna. vol.II, , Bari: EDIPUGLIA, 2009
- Licinio R., Castelli medievali. Puglia e Basilicata, dai Normanni a Federico II e Carlo d’Angio`, Castelli medievali. Puglia e Basilicata, dai Normanni a Federico II e Carlo d’Angio`, , Bari: , 1994
- Licinio R., Storia di Manfredonia. I. Il Medioevo, Storia di Manfredonia. I. Il Medioevo, , Bari: , 2008
- Mercurio F., Storia di Manfredonia. III.1. L'età contemporanea, Storia di Manfredonia. III.1. L'età contemporanea, , Bari: , 2010
- Russo S., Storia di Manfredonia. III2. L'età contemporanea., Storia di Manfredonia. III2. L'età contemporanea., , Bari: , 2010
- Serricchio C., Siponto-Manfredonia, Siponto-Manfredonia, , Foggia: , 2004
Scheda
- FGBIP000056
Condizione Giuridica
Proprietà mista
-
Tipo: Ente MiBAC
Ente: Segr. Reg. BBCC Puglia
Ruolo: Tutela e Valorizzazione
-
Tipo: Soprintendenze ambito archeologico
Ente: Sop. Archeologia Puglia
Ruolo: Tutela e Valorizzazione
-
Tipo: Soprintendenze ambito architettura-belle arti-paesaggio
Ente: Sop. Belle Arti BA-BAT-FG
Ruolo: Tutela e Valorizzazione
Periodo:
- Basso Medioevo (XI-XV secolo)
- Età contemporanea (XIX-XXI secolo)
- Età moderna (XVI -XVIII secolo)
Cronologia specifica:
Dal: XIII secolo Al: XXI secolo
Datazione Assoluta:
- XIII d.C. - XIV d.C. - XV d.C. - XVI d.C. - XVII d.C. - XVIII d.C. - XIX d.C. - XX d.C.Motivazione:
- Bibliografia
Criterio di perimetrazione: Evidenze da ortofoto
Tipo Fruibilità: Attrezzato per la fruizione