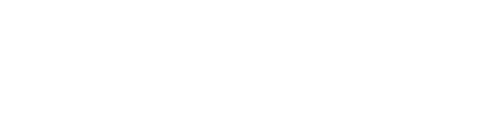Esplora la Carta
Dalla fotografia aerea del centro antico di Bitetto è possibile scorgere con puntualità geometrica l'impianto urbanistico poligonale, quasi un ottagono che si sviluppa radialmente a partire dal centro, grossomodo individuabile nell'angolo che si forma all'incrocio tra Via Giannini e Via XXIV Maggio. Della cinta muraria persiste un breve settore a completamento-aggancio di Porta Piscina: il fornice urbico bassomedievale è situato in corrispondenza della via che da Bitetto conduceva a Bari, a ridosso del palazzo baronale settecentesco. L'andamento murario pseudo-ottagonale è facilmente intuibile se si segue il tracciato degli abitati che lambiscono l'anello più esterno del borgo. La città di Bitetto, intesa come area pluristratificata nel corso della storia, contiene due siti corrispondenti ad altrettanti fasi storiche: Bitetto (città medievale), Bitetto (città moderna). Ad ogni sito riconducono diverse unità topografiche, edifici di culto e architetture civili costruite entro il compartimento cronologico del sito di riferimento. L'attestazione archivistica più datata che attesta la presenza di Bitetto, quale organismo urbanistico unitario, è riconducibile al X secolo, durante l'età catepanale: il documento stabilisce l'impegno degli abitanti residenti 'in loco Vitecte' a pagare un censo annuale all'Achidiocesi di Bari. Nel 1011 l'area dove oggi sorge la città fu il campo della battaglia tra il filo-normanno Melo di Bari e il catepanato bizantino. Nel corso dell'XI secolo Bitetto fu elevata a sede vescovile suffraganea della metropolia barese. La fondazione di Altamura e della sua cattedrale palatina per volere di Federico II comportò per decreto imperiale l'assoggettamento di Bitetto alla neonata città federiciana, dove si stabilirono molti bitettesi. Con l'ascesa degli Angioini, Bitetto fu tra le città più ricche della Terra di Bari: a questo periodo si datano diversi edifici del centro antico. La calata degli Ungheresi nella Puglia centrale per regolare la successione dinastica dopo Roberto d'Angiò interessò anche Bitetto, che nel 1349 fu saccheggiata e razziata. A partire dall'età moderna iniziarono i numerosi passaggi di proprietà dal demanio reale alle diverse casate feudatarie: in primis gli Arcamone e i de Attendolis, questi ultimi talmente autoritari da provocare l'allontanamento del vescovo. Nel corso del XV secolo si registrò il progressivo peggioramento delle condizioni della popolazione bitettese causati principalmente dalla forte ondata di peste del 1489. Nel 1731 il regio demanio borbonico sottrasse il feudo di Bitetto, comprendente anche Carbonara, Binetto, Erchie e Mesagne. Successivamente tornò sotto il governo feudale con il barone Francesco Noya di Mola di Bari, di origine fiamminga, che fece edificare nei pressi delle mura il suo palazzo.
- ANTONACCI DE MARCO R.,, Bitetto al tempo degli Acquaviva d'Aragona, ,1996
- ANTONACCI DE MARCO R.,, Bitetto nell'Età Borbonica, ,1993
Scheda
- BABIP000009
Condizione Giuridica
Proprietà Ente pubblico territoriale
-
Tipo: Soprintendenze ambito architettura-belle arti-paesaggio
Ente: Sop. Belle Arti BA-BAT-FG
Ruolo: tutela
Periodo:
- Età moderna (XVI -XVIII secolo)
- Basso Medioevo (XI-XV secolo)
- Età contemporanea (XIX-XXI secolo)
Cronologia specifica:
Motivazione:
- Analisi delle strutture
- Analisi stilistica
- Dati epigrafici
- Bibliografia
Criterio di perimetrazione: Perimetrazione effettuata in relazione all'ingombro degli edifici che insistono all'interno della cinta muraria bassomedievale
Tipo Fruibilità: Aperto al pubblico