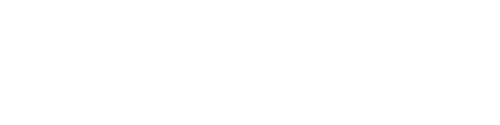Esplora la Carta
Alla luce dei rinvenimenti archeologici emersi nell’area di Bitonto è difficile localizzare con esattezza i confini topografici della città nelle fasi preromana e romana. Il sito è attestato come fiorente centro peucezio, mai divenuto colonia greca, pur essendo stato in contatto con le poleis magnogreche. Il toponimo Bytontynon già si legge nelle iscrizioni incise su alcune monete rinvenute nella necropoli di Via Traiana, la cui frequentazione è ascrivibile dall'età arcaica all'ellenismo: le attestazioni numismatiche, poste nelle tombe a completamento del vasto corredo funerario, sono caratterizzate da temi iconografici legati all'ulivo e alla dea Atena. Tale prassi cerimoniale è tipicamente riconducibile alla tradizione peuceta. Sia il vasellame che il deposito numismatico rinvenuti nella necropoli succitata sono conservati presso il Museo Archeologico della Fondazione De Palo-Ungaro di Bitonto. La fase romana di Bitonto coincide con la romanizzazione della Peucezia. Col toponimo Butuntum è annoverata nella periegesi del De Naturalis Historiae di Plinio il Vecchio, che la qualifica come municipium: da tale connotazione si deduce un profilo ben organizzato, quasi proto-urbano, di Bitonto nella sua fase romana. Un municipio quindi, non un villaggio rustico, caratterizzato da un assetto stradario abbastanza definito. A questo momento corrisponde l'acropoli individuabile nell'area dove oggi sorgono le chiese di San Francesco alla Scarpa e di San Pietro in Vincoli: quest'ultimo luogo di culto si sovrappone al preesistente tempio minervico, i cui fusti di colonne sono stati reimpiegati nella cripta della Cattedrale normanna. Tracce della viabilità romana sono leggibili in alcuni settori viari, riportati alla luce durante gli scavi condotti nel succorpo della Cattedrale, e in un frammento di cippo miliare, sempre situato su via Traiana, all'ingresso del cimitero comunale. Nel maggio 1991, il cedimento dei lastroni pavimentali riscontrato tra le navate centrale e sinistra della Cattedrale di Bitonto rese necessaria l'indagine archeologica che rivelò progressivamente un articolato palinsesto monumentale: un edificio basilicale orientato a tre navate separate da pilastri e unica abside, demolita nel corso bassomedioevo, a partire dalla fine del XI secolo, per impostare la cripta romanica 'a sala': l'edificio di culto è riconducibile all'età tardoantica. Esso s’imposta a sua volta su preesistenti abitazioni frequentate già in età peucezia e romana. La basilica è ridefinita nel corso dell'altomedioevo. Della basilica rimangono diverse porzioni del tappeto musivo a opus sectile, di gusto e tecnica esecutiva tipicamente paleocristiani, raffigurante un kantharos, dalla cui base si dipartono due nastri con foglie d'edera che lo incorniciano.
Definizione Ambito Culturale:
- Dato non disponibile
- AA. VV., Gli antichi Peucezi a Bitonto. Documenti ed immagini dalla necropoli di Via Traiana : EDIPUGLIA, 2003
- Fioriello C.S.M., Alcune note di archeologia bitontina, Studi Bitontini, 63, : , 1997
- Castellano A., Arte e civiltà dell'antica Bitonto, Studi Bitontini, 1, : , 1969
- Fioriello C.S.M., La romanizzazione della peucezia: Ruvo e Bitonto nella ricerca e nella storiografia archeologica, ,2000/2001
Scheda
- BABIS001980
Tipologia del bene
Tipo: Civitas
Funzione:
- Sacra/religiosa/culto
- Difensiva/militare
- Abitativa/residenziale
Condizione Giuridica
Proprietà mista
-
Tipo: Soprintendenze ambito archeologico
Ente: Sop. Archeologia Puglia
Ruolo: Tutela e valorizzazione
-
Relazione urbanistico ambientale [è in relazione urbanistico ambientale con] - Sito Pluristratificato
-
elemento contenuto in - Sito Pluristratificato
Periodo:
- Età tardoantica (IV -VI sec. d.C.)
- Età romana (generico)
- Età preromana (generico)
Motivazione:
- Analisi della stratigrafia
- Analisi delle strutture
- Bibliografia
- Asportato in seguito a scavo
- Rudere
Criterio di perimetrazione: Ingombro dei frammenti con strutture rinvenuti
Tipo Fruibilità: Altro (Specificare)