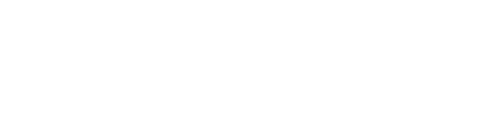Esplora la Carta
Alla fine del Settecento la necessità di una maggiore razionalità abitativa ed urbanistica, impossibile da stabilire nel borgo antico così densamente stratificato, spinge alla ricerca di nuovi spazi: al 1790 si data la prima richiesta di autorizzazione alla creazione di un nuovo borgo fuori dalle mura. La creazione del borgo si concretizzerà soltanto durante il breve regime napoleonico nel regno di Napoli, quando tra le importanti riforme realizzate durante questi anni, quali l’abolizione della feudalità (1806) e la trasformazione in senso moderno e razionale dell’amministrazione e della legislazione, Bari fu elevata a capoluogo provinciale a discapito di Trani (1808). Messe da parte le difficoltà opposte dai nobili proprietari dei terreni della zona extraurbana a ridosso del nucleo storico scelta per la realizzazione del borgo, nel 1812 l’architetto Gimma fu incaricato di redigere il piano dell’espansione, approvato da Murat nell’anno successivo. Il 9 aprile 1813 fu lo stesso Murat a porre la prima pietra del nuovo borgo, che da lui prenderà il nome. La realizzazione del borgo prese avvio di fatto nel 1815 nei pressi della piazza Mercantile e del porto, dallo spigolo N-E della scacchiera, costituita da isolati rettangolari regolari. L’espansione coinvolse soprattutto i nuovi proprietari, provenienti dalle zone limitrofe, mentre le famiglie nobili rimasero ancora a lungo nei loro palazzi nella città vecchia. Contestualmente fu intrapresa la costruzione del grande palazzo dell’Intendenza nello stradone che seguendo il percorso delle mura segna il confine tra vecchio e nuovo borgo. Nel 1817 fu demolita porta Castello, nel 1819 la cinta muraria. Nel 1826 erano già stati costruiti dieci isolati, di cui quattro sulla via del Mare, quattro al Corso, due sulle antiche vie della Cappella dei Santi, due sulla via di Carbonara e Altamura, l’espansione dunque avvenne gradualmente verso O e verso S. Negli anni successivi furono fondati la Camera di Commercio, nel 1829, e la Biblioteca pubblica, nel 1830, mentre il castello fu adibito a prigione il castello ed avviato alla decadenza. La nascita del borgo murattiano e la soppressione degli Ordini religiosi provocarono da un lato l'abbandono della città vecchia da parte delle famiglie più abbienti, che affittano o svendono i propri palazzi, avviandone la trasformazione in condomini malsani, dall'altro la conversione degli edifici monastici in caserme, prigioni ed ospizi. Nel 1840 una intera isola del nuovo borgo fu dedicata al teatro Piccinni, la sesta all’altezza del palazzo dell’Intendenza; nella quarta linea, la terza isola venne destinata alla chiesa di San Ferdinando. La via su cui essa si affaccia, via Sparano, ottenne una definitiva qualificazione funzionale e rappresentativa intorno alla seconda metà del secolo con l’arrivo della ferrovia e la scelta di collocare l’edificio della stazione sul suo stesso asse. La ferrovia, orientata lungo le strade del Borgo, costituì il nuovo limite artificiale alla progressione edilizia soltanto fino all’Unità d’Italia. Fino a questo momento la struttura urbana è progettata secondo le esigenze economiche di una classe borghese, con case piuttosto grandi, nel cui piano terra si ricavano magazzini o negozi, non sono previste abitazioni popolari. A partire dal 1880 sotto la spinta delle esigenze della nuova classe operaia si costituiranno nuovi quartieri periferici rispetto allo scacchiere murattiano, a ridosso delle fabbriche. Le nuove aree di espansione furono individuate ad O oltre la piazza borbonica, oggi intitolata a Garibaldi, e a di là della ferrovia. Nei quartieri Libertà, s. Pasquale e Carrassi sorsero i primi grossi edifici modulati su piccoli tagli. In margine alle grandi strade mediane che collegano Bari al suo hinterland si diffusero i primi villini borghesi, inframmezzati alle antiche ville e masserie della nobiltà barese. Nei primi anni del Novecento vengono progettati e realizzati importanti edifici contenitori di istituzioni, quali il palazzo di giustizia, il nuovo porto, la stazione. Nel 1903 fu inaugurato anche il Teatro Petruzzelli sulla più importante parallela a via Sparano, l’attuale corso Cavour, e nel 1914 la città si dotò di un terzo teatro il Margherita, realizzato su palafitte nell’ansa del vecchio porto. Negli anni del regime fascista si completa la sistemazione del lungomare fino a Piazza Diaz, trasformandolo nell’asse principale della città fascista nel quale si susseguono le sedi delle principali istituzioni del regime. In aree marginali furono collocati servizi di interesse regionali, quali il policlinico, l’ospedale militare e l’aeroporto civile, mentre il Palazzo delle Poste e la pretura si collocano in spazi residui del quadrilatero murattiano. Il secondo dopoguerra è stato poi segnato dalla massiccia espansione della città con la creazione di nuovi quartieri popolari satellite, dalla sostituzione di molti palazzi ottocenteschi e del borgo murattiano con nuovi edifici a più piani e complessi edilizi residenziali.
- AA. VV., Tateo F. a cura di, Storia di Bari. Il Novecento, Storia di Bari. Il Novecento, , Roma-Bari: , 1997
Scheda
- BABIS001828
Tipologia del bene
Tipo: Città
Funzione:
- Abitativa/residenziale
- Portuale
- Produttiva/lavorazione/artigianale
- Sacra/religiosa/culto
- Servizio
- Pubblica
- Funeraria
Condizione Giuridica
Proprietà mista
-
Tipo: Soprintendenze ambito architettura-belle arti-paesaggio
Ente: SABAP-FG (Archite-BA-Pae)
Ruolo: Tutela e valorizzazione
-
elemento contenuto in - Sito Pluristratificato
Periodo:
- Età contemporanea (XIX-XXI secolo)
Motivazione:
- Bibliografia
Cronologia specifica:
Dal: XIX d.C. Al: XXI d.C.
- Integro
Dimensioni in Mq: 49620000.00
Criterio di perimetrazione: Evidenze da ortofoto
Tipo Fruibilità: Attrezzato per la fruizione