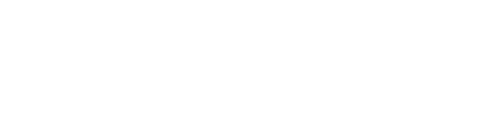Esplora la Carta
A Punta del Serrone, nel 1972 fu rinvenuto un piede di statua colossale dai sub brindisini B. Antelmi, G. Vola, D. Caiulo; nel 1992 L. Robusto e altri subacquei locali individuarono altre sculture. Il carico era composto da statue frammentarie di alta qualità, eterogenee sotto l’aspetto tipologico e prodotte nell’arco di parecchi secoli. Sui reperti non si riscontrano codoli di fusione: va pertanto escluso che si tratti di “scarti di officina”; le sculture recano segni di finitura superficiale e tasselli ribattuti - applicati per nascondere difetti di fusione o tracce di corrosione - e quindi sono opere finite, verosimilmente demolite dopo un periodo di esposizione; i frammenti di grandi dimensioni sono caratterizzati da terminali distorti o fratturazioni provocate in antico in corrispondenza dei punti di giunzione fra le parti, mediante colpi violenti inferti deliberatamente; la demolizione violenta induce ad escludere un trasporto dei bronzi in quanto “opere d’arte” o “bottino di guerra”; è invece probabile che le statue - ridotte in frammenti - fossero destinate alla fusione. L'ipotesi più recente circa l'origine delle statue è stata formulata da K. Mannino, che riconosce un consistente nucleo di sculture risalenti al II secolo d.C., raffiguranti personaggi privati e della famiglia imperiale. Fra questi un’importanza centrale riveste senza dubbio Polydeukion (la statua del c.d. togato), un giovane allievo del prestigioso sofista Erode Attico, il “miliardario” ateniese vicino ad Adriano, Antonino Pio e Marco Aurelio. Statue di Polydeukion erano collocate in Grecia sia nelle ville di proprietà di Erode Attico sia in scenografici edifici monumentali costruiti o restaurati dal sofista. In relazione con Erode Attico si possono mettere anche altre sculture del carico: la statua di bambina - di cui si conservano esclusivamente la testa e un braccio che si confronta con le principesse della famiglia di Marco Aurelio attestate nel Ninfeo che il sofista aveva eretto ad Olimpia; la testa femminile caratterizzata da un’acconciatura analoga a quella di Faustina Minore trova riscontro in alcuni ritratti provenienti dall’Attica forse raffiguranti Annia Regilla, moglie di Erode Attico; il ritratto del principe Elio Cesare - adottato da Adriano e padre di Lucio Vero - è presente fra le sculture che ornavano la villa di Erode Attico individuata a Loukoù - l’antica Eua - nel Peloponneso. Il complesso di statue marmoree di Loukoù presenta stringenti affinità con la documentazione bronzea brindisina: analogo, in particolare, appare il criterio che regola la selezione delle sculture. Fra le statue di Punta del Serrone troviamo infatti personaggi contemporanei vicini ad Erode Attico (membri della famiglia imperiale e di quella del sofista; giovani allievi), statue-ritratto greche raffiguranti filosofi, personaggi storici (il “principe ellenistico”), varie statue di divinità (originali ellenistici come la Nike; copie ed elaborazioni di capolavori dell’arte greca come la statua colossale di divinità femminile o quella raffigurante Apollo citaredo). Il c.d. principe era stato precedentemente identificato da P. Moreno con un originale ellenistico di committenza romana, della seconda metà del II sec. a.C., raffigurante L. Emilio Paolo vincitore di Perseo re di Macedonia a Pidna nel 168 a.C., mancante del pallio, fuso a parte, come gli arti, rispetto al torso; sulla spalla destra, presso la base del collo, sono incise due lettere greche a formare una cifra: kappa ed epsilon lunata = 25, probabilmente il numero di inventario all'interno di una raccolta o collezione da situare nel mondo greco o comunque orientale. Quest’insieme di elementi induce ad ipotizzare la provenienza da una delle ville di Erode Attico o, in alternativa, da un imponente complesso monumentale adorno di statue dedicate dal mecenate. La scarsa profondità ed il fondale roccioso, caratterizzato da piccole dorsali, conche e fenditure, non hanno consentito la conservazione del legno. Oltre ai materiali bronzei sono stati recuperati alcuni oggetti che potrebbero riferirsi all’armamento di una o più imbarcazioni: uno scandaglio in piombo campaniforme, una puleggia di legno, vari frammenti di lamine di piombo utilizzate come rivestimento del fasciame, per proteggerlo dal degrado e dalla teredine; un “foglio” in piombo ripiegato poteva servire come riserva di bordo per le riparazioni. Non è detto che tutti questi manufatti provengano dall’imbarcazione che trasportava il carico bronzeo. Il rivestimento in piombo dell’opera viva della nave non si riscontra sulle imbarcazioni della media e tarda età imperiale romana, come questa di Punta del Serrone, ma in quelle precedenti. Anche l’ancora di ferro, ancora riconoscibile nella ganga concrezionata rinvenuta vicina ad alcune tegole, sembra appartenere al tipo a “freccia rovesciata”, più antico di quello a marre curve diffuso in età augustea e pertanto non attribuibile ad un contesto tardoantico, come pare essere la nave dei bronzi. Alcuni mattoni, tegole e coppi potrebbero essere i resti di una “zavorra vendibile”, come accadeva solitamente per i carichi di materiale laterizio, oppure provenire dalla copertura di una “cabina/cambusa”; meno verosimile è la pertinenza ad un piano di cottura di una cucina di bordo, perché non recano tracce di annerimento da fuoco. Altri reperti sono riferibili alla dotazione di bordo, sempre di una o più imbarcazioni: frammenti di anfore, di cronologia e produzione diversa (grecoitaliche recenti/Lamboglia 2, ovoidali adriatiche di produzione salentina, tipo Apani III di cui un frammento con bollo PVLADE, anfore orientali Mid Roman 3, Late Roman 1a e altre non identificate); frammenti di vasellame comune (piatti, pentole, olle, brocche ), per l’uso dell’equipaggio. Una serie di reperti è identificabile con attrezzatura alieutica: pesi da rete in piombo (piccole lamine di piombo rettangolari ripiegate longitudinalmente a metà o arrotolate, talvolta con un motivo di reticolato graffito), corpo morto litico di forma approssimativamente trapezoidale, con un foro per la cima di sospensione, ed altri pesi in ceramica. Un anello in piombo, invece, con un’aletta con il foro di attacco per la sagola, doveva essere probabilmente impiegato per il recupero di ami o di ormeggi impigliati tra le rocce del fondale. Il pesce era ovviamente l’alimento fondamentale nella dieta dei marinai impegnati sulle navi da carico, ma gli oggetti rinvenuti potrebbero semplicemente segnalare il passaggio e la reiterata attività di piccole barche da pesca. Altri oggetti metallici sono stati rinvenuti successivamente nell'area: lucerne in bronzo, casseruole, stadere, ecc.(SRI 308), un cursore/peso raffigurante busto di Minerva (SRI 445). I confronti individuati per la documentazione bronzea suggeriscono la Grecia come ambito sia di produzione delle statue sia, in alcuni casi, di esclusiva o precipua circolazione dei tipi iconografici.
- Auriemma R., Salentum a salo. Forma Maris Antiqui. Volume secondo, , II, : Congedo Editore, 2004
Scheda
- BRBIS001775
Tipologia del bene
Tipo: Relitto
Funzione:
- Navigazione
Condizione Giuridica
Proprietà Stato
-
Tipo: Università statale
Ente: Università del Salento
Ruolo: Ricerca
-
Tipo: Soprintendenze ambito archeologico
Ente: Sop. Archeologia Puglia
Ruolo: Tutela
Periodo:
- Età tardoantica (IV -VI sec. d.C.)
Motivazione:
- Analisi dei materiali
- Contesto
- Materiali
- Conservato parzialmente
Criterio di perimetrazione: Individuato nel 1972