Esplora la Carta
In località Scala di Furnu-Torre Chianca, a N-O di Porto Cesareo (LE), appena fuori la direttrice che congiunge la scogliera su cui sorge Torre Chianca con l'isolotto Lu Scueiu, nell’agosto del 1960 è stata fatta una segnalazione da R. Congedo circa la presenza di materiale archeologico in mare. Si tratta, nel dettaglio, di 5 colonne monolitiche (Congedo ne aveva segnalate 7), in posizione perfettamente parallela, orientate in direzione N-S e distanti tra loro cm 50 circa, incrostate di depositi calcarei. Esse sono lunghe m 9, con un diametro che oscilla tra cm 70 e 100 e sono di marmo cipollino di Caristos (sono stati prelevati e analizzati dei campioni). Tra il primo ed il secondo monolite (da est) si trova un manufatto probabilmente di piombo, caratterizzato da una forma triangolare e dalla presenza di numerose scanalature, schiacciato sotto le colonne. La seconda presenta un lungo spacco trasversale (che il Congedo giudica recente). Tutte si presentano a lavorazione non ultimata. Un blocco parallelepipedo giace perpendicolarmente rispetto alle colonne, immediatamente a N di esse, mentre un altro, scoperto solo per una lunghezza di cm 60, si trova a fianco del manufatto metallico, sempre al di sotto della colonna, disposto in direzione N-S. Nel 1964 furono inoltre recuperati 14 frammenti di marmo di varie dimensioni e qualità, in prevalenza lastriforme (n. inv. 205177) [s. 96/179]. Nello stesso anno furono recuperati numerosi reperti tra cui 3 frammenti di embrici: il primo (n. inv. 205165) è di cm 21 x 24 e presenta un impasto ricco di inclusi di mudstone, analogo a quelle delle anfore corinzie A; il secondo (n. inv. 205166) è di cm 21 x 18 con impasto giallo piuttosto polveroso, con numerosi inclusi neri, piccolo, medi e grandi, simile a quello delle anfore corinzie B; infine il terzo (n. inv. 205167) è di cm 19 x 18 con impasto rosaceo piuttosto depurato [s. 96/178]. Tra il materiale recuperato si segnalano anche frammenti di un tegame (nn. Inv. 205174-5) il cui colore dell’impasto ricorda quello delle anfore chiote [s. 96/180]; un piede a bottone di anfora non id., probabilmente tasia (nell'I.G. tappo di anfora vinaria attribuibile ai tipi chioti per l'impasto), (n.inv.205174) con un diametro di cm 8 e un’altezza massima di cm 4 [s. 96/180]; un fondo troncoconico di anfora, conservato in 2 frammenti e privo di puntale, non id. (probabilmente tasia, nell'I.G. anfora vinaria chiota) (n. inv. 205172), conservato per un’altezza massima di cm 16 [s. 96/181]; 6 pesetti fittili da rete (n.inv.205176) [s. 96/182]; un collo frammentario di anfora Trip. III, conservata per un’altezza massima di cm 17, caratterizzata da un diametro dell’orlo di cm 12 e da un impasto rosso arancio (frattura netta) con inclusi rossicci, piccoli e piccolissimi, all'interno del collo è visibile una impressione digitale per l'attaccatura dell'ansa (n. inv. 205169 TC 64/8) [ss. 96/183-184]; e infine un collo frammentario di una probabile produzione africana (Afr. II A similis) con argilla rossa con inclusi bianchi, caratterizzata da un orlo con sezione a mandorla e anse a maniglia, si conserva per un’altezza di cm 18.5 (n. inv. 205168?) (non ben leggibile; le misure non corrispondono perfettamente a quelle del reperto nell'I.G.:fr. Orlo, collo, ansa di anfora vinaria imperiale) TO/C 64/8 ? (64/2 ?) [s. 96/185]. Nel 1994 nell'area circostante fu effettuata una prospezione con l'ausilio della sorbona, a seguito della quale è stato individuato unicamente materiale fittile, in gran parte anfore e laterizi, frammentato ed eterogeneo: si sono infatti riconosciute sia produzioni di epoca classica, sia tardoantiche (BORRICELLI - ZACCARIA 1995).Nel 1996 su informazione di F. Zongolo è stato notato marmo sotto le colonne (cfr. s.96/101). P.Throckmorton stima il carico attorno alle 120 tonnellate ma parla di 4 colonne (cfr. relitto di T. Sgarrata SR 48). Si ipotizza che il tonnellaggio della nave potesse essere di circa 120 tonnellate. Probabilmente la nave perseguiva la rotta Egeo - Roma (?). La sua cronologia può essere attribuita tra la fine del II e tutto il III sec. d.C. (anche inizi IV). I materiali sono ancora in situ. Confronti su questo tipo di imbarcazione è possibile vederli nel Relitto di Capo Cimiti con un carico costituito da sei fusti in cipollino verde (PENSABENE 2000a, p. 40, n. 9.Cfr. colonne in marmo caristio del Tempio di Antonino e Faustina: dimensioni in PENSABENE 1994, p.308). [Per la Trip.III, v. Ostia IV, pp.154-156; un buon confronto è offerto da materiale delle stratigrafie ostiensi: ibidem, fig.267; cfr. anche Sabratha 1989, p.40 ss.] In località Scala di Furnu-Torre Chianca, a N-O di Porto Cesareo (Le), appena fuori la direttrice che congiunge la scogliera su cui sorge Torre Chianca con l'isolotto Lu Scueiu, nell’agosto del 1960 è stata fatta una segnalazione da R. Congedo circa la presenza di materiale archeologico in mare. Si tratta, nel dettaglio, di 5 colonne monolitiche (Congedo ne aveva segnalate 7), in posizione perfettamente parallela, orientate in direzione N-S e distanti tra loro cm 50 circa, incrostate di depositi calcarei. Esse sono lunghe m 9, con un diametro che oscilla tra cm 70 e 100 e sono di marmo cipollino di Caristos (sono stati prelevati e analizzati dei campioni). Tra il primo ed il secondo monolite (da est) si trova un manufatto probabilmente di piombo, caratterizzato da una forma triangolare e dalla presenza di numerose scanalature, schiacciato sotto le colonne. La seconda presenta un lungo spacco trasversale (che il Congedo giudica recente). Tutte si presentano a lavorazione non ultimata. Un blocco parallelepipedo giace perpendicolarmente rispetto alle colonne, immediatamente a N di esse, mentre un altro, scoperto solo per una lunghezza di cm 60, si trova a fianco del manufatto metallico, sempre al di sotto della colonna, disposto in direzione N-S. Nel 1964 furono inoltre recuperati 14 frammenti di marmo di varie dimensioni e qualità, in prevalenza lastriforme (n. inv. 205177) [s. 96/179]. Nello stesso anno furono recuperati numerosi reperti tra cui 3 frammenti di embrici: il primo (n. inv. 205165) è di cm 21 x 24 e presenta un impasto ricco di inclusi di mudstone, analogo a quelle delle anfore corinzie A; il secondo (n. inv. 205166) è di cm 21 x 18 con impasto giallo piuttosto polveroso, con numerosi inclusi neri, piccolo, medi e grandi, simile a quello delle anfore corinzie B; infine il terzo (n. inv. 205167) è di cm 19 x 18 con impasto rosaceo piuttosto depurato [s. 96/178]. Tra il materiale recuperato si segnalano anche frammenti di un tegame (nn. Inv. 205174-5) il cui colore dell’impasto ricorda quello delle anfore chiote [s. 96/180]; un piede a bottone di anfora non id., probabilmente tasia (nell'I.G. tappo di anfora vinaria attribuibile ai tipi chioti per l'impasto), (n.inv.205174) con un diametro di cm 8 e un’altezza massima di cm 4 [s. 96/180]; un fondo troncoconico di anfora, conservato in 2 frammenti e privo di puntale, non id. (probabilmente tasia, nell'I.G. anfora vinaria chiota) (n. inv. 205172), conservato per un’altezza massima di cm 16 [s. 96/181]; 6 pesetti fittili da rete (n.inv.205176) [s. 96/182]; un collo frammentario di anfora Trip. III, conservata per un’altezza massima di cm 17, caratterizzata da un diametro dell’orlo di cm 12 e da un impasto rosso arancio (frattura netta) con inclusi rossicci, piccoli e piccolissimi, all'interno del collo è visibile una impressione digitale per l'attaccatura dell'ansa (n. inv. 205169 TC 64/8) [ss. 96/183-184]; e infine un collo frammentario di una probabile produzione africana (Afr. II A similis) con argilla rossa con inclusi bianchi, caratterizzata da un orlo con sezione a mandorla e anse a maniglia, si conserva per un’altezza di cm 18.5 (n. inv. 205168?) (non ben leggibile; le misure non corrispondono perfettamente a quelle del reperto nell'I.G.:fr. Orlo, collo, ansa di anfora vinaria imperiale) TO/C 64/8 ? (64/2 ?) [s. 96/185]. Nel 1994 nell'area circostante fu effettuata una prospezione con l'ausilio della sorbona, a seguito della quale è stato individuato unicamente materiale fittile, in gran parte anfore e laterizi, frammentato ed eterogeneo: si sono infatti riconosciute sia produzioni di epoca classica, sia tardoantiche (BORRICELLI - ZACCARIA 1995).Nel 1996 su informazione di F. Zongolo è stato notato marmo sotto le colonne (cfr. s.96/101). P.Throckmorton stima il carico attorno alle 120 tonnellate ma parla di 4 colonne (cfr. relitto di T. Sgarrata SR 48). Si ipotizza che il tonnellaggio della nave potesse essere di circa 120 tonnellate. Probabilmente la nave perseguiva la rotta Egeo - Roma (?). La sua cronologia può essere attribuita tra la fine del II e tutto il III sec. d.C. (anche inizi IV). I materiali sono ancora in situ. Confronti su questo tipo di imbarcazione è possibile vederli nel Relitto di Capo Cimiti con un carico costituito da sei fusti in cipollino verde (PENSABENE 2000a, p. 40, n. 9.Cfr. colonne in marmo caristio del Tempio di Antonino e Faustina: dimensioni in PENSABENE 1994, p.308). [Per la Trip.III, v. Ostia IV, pp.154-156; un buon confronto è offerto da materiale delle stratigrafie ostiensi: ibidem, fig.267; cfr. anche Sabratha 1989, p.40 ss.]
- Auriemma R., Salentum a salo. Forma Maris Antiqui. Volume secondo, , II, : Congedo Editore, 2004
Scheda
- LEBIS001740
Tipologia del bene
Tipo: Relitto
Funzione:
- Abitativa/residenziale
- Navigazione
Condizione Giuridica
Proprietà Stato
-
Tipo: Università statale
Ente: Università del Salento
Ruolo: Ricerca
-
Tipo: Soprintendenze ambito archeologico
Ente: Sop. Archeologia Puglia
Ruolo: Tutela
Periodo:
- Età romano imperiale (I-III sec. d.C.)
Motivazione:
- Analisi dei materiali
- Contesto
- Materiali
- Prospezioni
- Conservato parzialmente
Criterio di perimetrazione: Rilievi ad opera del gruppo di Archeologia Subacquea dell'Università del Salento
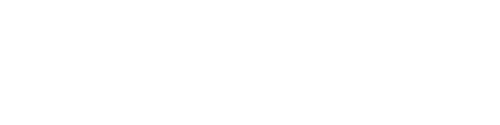








. Il relitto delle colonne (1446198001).jpg)