Esplora la Carta
Contesto trogloditico situato in località Pulsano, pochi chilometri a sud-ovest di Monte Sant’Angelo caratterizzato da un articolato sistema di ipogei rupestri e semirupestri, posti attorno ad un complesso abbaziale di origine medievale. Gli eremi sono dislocati lungo i costoni rocciosi delle valli di Monteleone e Matino, dei Romiti e Campanile che, incrociandosi presso il complesso religioso, discendono verso la sottostante piana di Macchia e il litorale sipontino. Sulla punta del pianoro si situa l'Abbazia di Santa Maria di Pulsano, sorta a partire dal XII secolo attorno ad una prima comunità eremitica, nota come Ordine Monastico degli Eremiti Pulsanesi, promossa da Giovanni Scalcione da Matera. Non si può escludere, tuttavia, una frequentazione precedente all'instaurazione dell'Ordine, sebbene manchino attestazioni materiali; lo stesso complesso eremitico riecheggia infatti contesti bizantini e orientali. Nelle opere sulla vita del fondatore, S. Giovanni Eremita, sono ricordati numerosi 'contemplanti', ovvero monaci che si consacravano ad una stretta vita eremitica, in celle realizzate sugli speroni della valle, che prese perciò il nome di 'vallone dei romiti'. L’abbazia, che ospita oggi una nuova comunità monastica, si sviluppa attorno alla chiesa che rappresenta il nucleo principale del complesso monastico. Allo stato attuale delle conoscenze, è possibile ipotizzare che le strutture ipogeiche, completamente naturali o parzialmente costruite, siano servite come nuclei abitativi o luoghi preposti all'attività agricola di una comunità che per il culto gravitava attorno all’abbazia. Un primo stanziamento rupestre si daterebbe quindi ad una fase precedente o contemporanea alla nascita dell'Ordine, agli inizi del XII secolo; l'ampliamento di questi nuclei legato all'intensificarsi delle attività agricole e pastorali, che vede la realizzazione di nuove strutture, terrazzamenti e recinzioni, potrebbe essere contestuale allo sviluppo dell'Ordine monastico e dell'Abbazia, con la crescita delle proprietà, che avvenne nel corso del XIII secolo. Non si può escludere, tuttavia, che l'articolazione in più strutture degli eremi e la realizzazione anche di spazi sacri al loro interno, corrisponda invece alla crisi dell'Abbazia in età moderna, fra XV e XVII secolo; tale datazione è suggerita anche dai tratti degli affreschi superstiti e dalle tecniche costruttive murarie, e dal diffondersi di un interessante fenomeno di vita eremitica praticato frequentemente in quest'epoca. Negli atti della visita pastorale dell’arcivescovo Vincenzo Maria Orsini del 1678, sono ancora ricordati numerosi romiti che vivevano sparsi nella contrada di Pulsano, per cui l'arcivescovo ordinò che fossero associati come in una congregazione e che vi fosse nominato un apposito superiore; gli ultimi eremiti sono attestati nel 1723. L’habitat rupestre si articola in una serie di complessi distinti, raggiungibili attraverso un lungo camminamento creato sul costone roccioso, talvolta caratterizzato da ripide scale a gradini. Alcuni eremi presentano un’articolazione in più ambienti, posti talora anche su diversi livelli, o ulteriori superfici (soppalchi o cantine), utilizzabili come deposito, magazzino, ripostiglio o struttura funzionale. Si riscontra nella maggior parte dei casi una combinazione di spazi rupestri e vani in muratura. Gli apparati murari sono connotati da pietre informi, più solide e grosse alla base, prive di lavorazione e poste in opera senza corsi regolari, con malta abbondante e tenace. Numerosi fori per l’alloggiamento di pali documentano la presenza di strutture lignee o in materiale deperibile, per la suddivisione interna degli spazi, per solai, imposte o recinzioni. Frequente è anche la creazione di aree esterne scoperte, ma recintate e protette, antistanti le grotte stesse, oppure la realizzazione di muri imponenti con funzione di terrazzamento e contenimento, edificati per garantire, in un contesto di forte pendio, la tenuta di piccoli appezzamenti di terreno in piano. Tali aree erano destinate a piccole attività agricole, produttive o per la sosta e ricovero degli animali. Si crearono in tal modo dei complessi ipogei costituiti da perimetri murari che delimitavano gli antri naturali, integrati da avancorpi costruiti e da corti aperte e talora articolati su due o più terrazze. L’ingresso a questi nuclei era spesso costituito da portali nei cui stipiti si manifestava l’unica attenzione alla lavorazione e squadratura dei blocchi di pietra. I resti di camini, lettiere, nicchie, armadi, canalette, cisterne, vaschette, abbeveratoi, macine per olive, neviere, silos, muri di contenimento documentano archeologicamente l’adattamento degli spazi per l’insediamento umano e lo svolgersi di attività domestiche, produttive, agricole e pastorali. Nelle strutture più articolate, non mancano ambienti completamente dedicati al culto, connotati dalla presenza di altari e affreschi alle pareti. La denominazione degli eremi deriva da una lunga tradizione orale riportata da studiosi locali e di cui conservano ancora memoria i monaci pulsanensi. La prima attestazione del nome di alcuni eremi si trova in Keyserlingk 1968, il quale in uno schizzo topografico, seppur con con evidenti errori di posizionamento o attribuzione, riporta i seguenti nomi: S. Giovanni da Matera, Pinnacolo, Mulino, Studio, Mandrie, Rondinella, Cantina, Prigione, S. Margherita, S. Nicola, Sant’Arcangelo; il resto dei nomi è tratto da Cavallini 1999, il quale su di una poco chiara e precisa mappa indica oltre ai citati, anche i seguenti eremi: S. Caterina Megalomartire, Pietre, S. Giorgio Megalomartire, S. Gregorio Magno, S. Spiridione, S. Simeone, S. Trifone, S. Plemone, S. Basilio, Sant’Antonio il Grande, S. Benedetto, S. Mauro e S. Pacomio.
Definizione Ambito Culturale:
- Dato non disponibile
- Favia P., Nuclei abitativi ed installazioni produttive rupestri nel Gargano fra Medioevo ed Età Moderna. Prime acquisizioni di ricerca., Insediamenti rupestri di età medievale: abitazioni e strutture produttive. Italia centrale e meridionale,2008
- Cavallini A., Santa Maria di Pulsano. Il santo desertico monastico garganico, ,1999
- Angelillis C., Pulsano e l'ordine monastico pulsanense, Archivio Storico Pugliese, VI,1953
- von Keyserlingk A., Vergessene Kulturen in Monte Gargano, Vergessene Kulturen in Monte Gargano, , Norimberga: , 1968
- Favia P., Giuliani R., De Minicis E. a cura di, Il cosiddetto “eremo” di Santa Margherita presso l’Abbazia garganica di S. Maria di Pulsano: una cellula di insediamento rupestre tra vocazione religiosa del contesto e utilizzo agricolo-pastorale., Insediamenti rupestri di età medievale: l’organizzazione dello spazio nella mappatura dell’abitato. Italia centrale e meridionale., II, Roma: , 2011
- Monaco F., Insediamenti rupestri nel Gargano medievale: nuclei abitativi, religiosi ed installazioni produttive. Tesi di dottorato, Insediamenti rupestri nel Gargano medievale: nuclei abitativi, religiosi ed installazioni produttive. Corso di Dottorato Storia e Archeologia Globale dei Paesaggi, Università degli Studi di Foggia, , Foggia: , 2013
Scheda
- FGBIS004096
Tipologia del bene
Tipo: Insediamento rupestre
Funzione:
- Sacra/religiosa/culto
- Produttiva/lavorazione/artigianale
- Abitativa/residenziale
- Assistenziale/ospitaliera
- Agricola
Condizione Giuridica
Proprietà privata
-
Tipo: Soprintendenze ambito archeologico
Ente: SABAP-FG (Archeologia)
Ruolo: Tutela e valorizzazione
-
Tipo: Soprintendenze ambito architettura-belle arti-paesaggio
Ente: SABAP-FG (Archite-BA-Pae)
Ruolo: Tutela e valorizzazione
Periodo:
- Basso Medioevo (XI-XV secolo)
- Età moderna (XVI -XVIII secolo)
- Età contemporanea (XIX-XXI secolo)
- Età tardoantica (IV -VI sec. d.C.)
- Alto Medioevo (VII-X secolo)
Motivazione:
- Analisi delle strutture
- Analisi stilistica
- Analisi tipologica
- Bibliografia
- Conservato parzialmente
Criterio di perimetrazione: Perimetrazione dell'area interessata dai singoli eremi effettuata su ortofoto.
Tipo Fruibilità: Aperto al pubblico
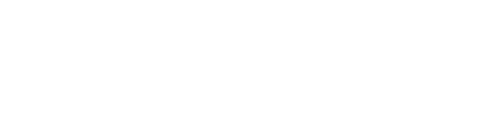








.JPG)
.JPG)
 (1593552238).jpg)
.JPG)
 (1593552323).jpg)
 (1593552394).JPG)
 (1593552418).jpg)
.JPG)
 (1593552461).JPG)