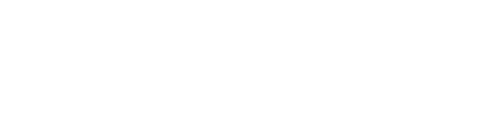Esplora la Carta
Definita, nei documenti più antichi che la riguardano, come terra Trium Sanctorum (XII sec.), la zona di Tressanti era attraversata nell'antichità da numerose vie con funzione commerciale, sia in età romana che in età medievale dopo l'istituzione della transumanza. Dopo Federico II, Tressanti divenne proprietà della Curia Pontificia e Innocenzo IV (1195-1254) la infeudò alla famiglia Capocci. Nei documenti il feudo di Tressanti viene identificato con un vero e proprio castrum cioè un luogo fortificato e la sua storia si intreccia con quella di Cerignola, proprio perché, nei passaggi feudali, le due terre vengono concesse in feudo abbinate. Questo avviene sia con Simone de Parisiis, primo feudatario di Cerignola sotto gli Angioini, sia per i monaci dell'Ordine Teutonico, che ricevono in feudo terre di Cerignola e terre di Tressanti, sia per i Caracciolo, che divengono feudatari di Cerignola e Tressanti. Con l'istituzione della Dogana delle Pecore, da parte di Alfonso I d'Aragona (1447), Tressanti diventa proprio una delle 23 locazioni in cui fu suddivisa la Capitanata. Uno dei passaggi determinanti nella storia della terra di Tressanti fu l'acquisto del territorio nel 1598 da parte della Certosa di San Martino di Napoli per una estensione di 6000 ettari. Considerata fino ad allora una masseria minore della Capitanata, divenne un'importante centro produttivo e un importante fonte di reddito per i Certosini di Napoli, fino alla prima metà del XVIII secolo, quando una crisi economica prima e il grande terremoto di Capitanata del 1731 misero a dura prova le produzioni di Tressanti e distrussero quasi completamente il borgo. Incamerata nel 1808 tra i beni dei monasteri soppressi, dopo il 1815 passa alla dotazione della Casa Reale borbonica; unificata dal punto di vista amministrativo ai beni di Santa Cecilia e di Paglicci, nel 1827 entra a far parte dell'Amministrazione di Puglia del Duca di Calabria, e più tardi del 'maggiorasco' del conte di Trani, figlio di Ferdinando II. Dopo l'Unità, come gli altri beni della Casa Reale Borbonica, Tressanti passa al Demanio e viene aggiudicata nel 1868 dalla Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali. Dopo numerosi passaggi, nel secondo Dopoguerra, diviene proprietà dell'Ente di Riforma Fondiaria che opera in tutta la zona importanti operazioni di bonifica. Oltre alle bonifiche l'ente di Riforma fa costruire numerose case coloniche sparse per le campagne e l'ampliamento dell'insediamento di Tressanti che trasforma in una vera e propria borgata rurale; infatti nel 1975 vengono costruiti diversi nuovi edifici e quasi tutto il vecchio borgo, con la chiesa di San Giuseppe e il convento dei Certosini, fu raso al suolo per ospitare un centro di produzione vinicola. Dell'originario complesso masseriale oggi restano visibili solo una parte della recinzione e una vecchia posta ad arcate con copertura a falde poco fuori dal recinto, entrambi allo stato di rudere.
Notizie storico-critiche:
- L'area di Tressanti è definita, nei documenti più antichi che la riguardano, come terra Trium Sanctorum (XII sec.)
- Dopo Federico II, Tressanti divenne proprietà della Curia Pontificia e Innocenzo IV (1195-1254) la infeudò alla famiglia Capocci. Nei documenti il feudo di Tressanti viene identificato con un vero e proprio castrum cioè un luogo fortificato e la sua storia si intreccia con quella di Cerignola, proprio perché, nei passaggi feudali, le due terre vengono concesse in feudo abbinate. Questo avviene sia con Simone de Parisiis, primo feudatario di Cerignola sotto gli Angioini, sia per i monaci dell'Ordine Teutonico, che ricevono in feudo terre di Cerignola e terre di Tressanti, sia per i Caracciolo, che divengono feudatari di Cerignola e Tressanti.
- Con l'istituzione della Dogana delle Pecore, da parte di Alfonso I d'Aragona (1447), Tressanti diventa proprio una delle 23 locazioni in cui fu suddivisa la Capitanata.
- Nel 1598 Tressanti fu acquisita da parte della Certosa di San Martino di Napoli per una estensione di 6000 ettari. Considerata fino ad allora una masseria minore della Capitanata, divenne un'importante centro produttivo e un importante fonte di reddito per i Certosini di Napoli, fino alla prima metà del XVIII secolo, quando una crisi economica prima e il grande terremoto di Capitanata del 1731 misero a dura prova le produzioni di Tressanti e distrussero quasi completamente il borgo.
- Incamerata nel 1808 tra i beni dei monasteri soppressi, dopo il 1815 passa alla dotazione della Casa Reale borbonica; nel 1827 entra a far parte dell'Amministrazione di Puglia del Duca di Calabria, e più tardi del 'maggiorasco' del conte di Trani, figlio di Ferdinando II.
- Dopo l'Unità, Tressanti passa al Demanio e viene aggiudicata nel 1868 dalla Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali. Dopo numerosi passaggi, nel secondo Dopoguerra, diviene proprietà dell'Ente di Riforma Fondiaria che fa costruire numerose case coloniche sparse per le campagne e procede all'ampliamento dell'insediamento di Tressanti. Nel 1975 vengono costruiti diversi nuovi edifici e quasi tutto il vecchio borgo, con la chiesa di San Giuseppe e il convento dei Certosini, fu raso al suolo per ospitare un centro di produzione vinicola.
- Sinisi F., Sinisi F. a cura di, Tressanti. Storia di un antico borgo, Tressanti. Storia di un antico borgo, , Cerignola: , 1998
Scheda
- FGBIS003348
Tipologia del bene
Tipo: Masseria
Funzione:
- Produttiva/lavorazione/artigianale
- Abitativa/residenziale
Condizione Giuridica
Proprietà privata
-
Tipo: Soprintendenze ambito architettura-belle arti-paesaggio
Ente: SABAP-FG (Archite-BA-Pae)
Ruolo: Tutela
Periodo:
- Età contemporanea (XIX-XXI secolo)
- Età moderna (XVI -XVIII secolo)
- Basso Medioevo (XI-XV secolo)
Motivazione:
- Bibliografia
- Documentazione
- Distrutto
- Conservato parzialmente
- Danno grave
Criterio di perimetrazione: Fonti bibliografiche
Tipo Fruibilità: Aperto al pubblico