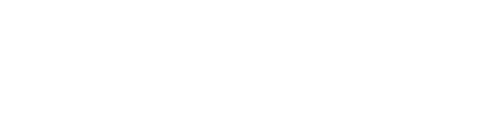Esplora la Carta
A partire dal VI secolo Bari fu, al pari del resto della Puglia centro settentrionale, contesa tra le varie fazioni in guerra, Goti, Bizantini, Longobardi. Questi ultimi si insediarono stabilmente dalla fine del VII secolo, includendo la città nel gastaldato di Canosa. Un gastaldato autonomo barese sarebbe sorto soltanto nei primi decenni del IX secolo generando una ripresa dell'espansione urbana ed un incremento della popolazione. Nell'VIII-IX secolo la città si amplia verso sud-ovest seguendo la costa in corrispondenza del porto e si dota di una nuova cinta muraria con una porta principale sulla strada per Canosa ed una Porta Nova, attestata per la prima volta nel 1057, situata nella parte orientale della città, verso sud-est, cioè verso Ceglie. A questo periodo potrebbe risalire l'impianto planimetrico del Portico dei Pellegrini, un edificio di fronte alla chiesa di S. Nicola, nel quale si è riconosciuto un ricordo della laubia dove in età longobarda si amministrava la giustizia. Tra l'847 e l'871 Bari diventa sede di un emirato arabo. Proprio in questo periodo la città comincia ad assumere una notevole importanza strategica e politica. Conquistata nell'871 dall'imperatore franco Ludovico II, è reintegrata nel principato di Benevento; ma già nell'875/876 è consegnata a Bisanzio dal gastaldo locale che temeva un attacco arabo. Dopo essere stata la base principale per la riconquista bizantina dell'Italia meridionale, Bari diviene nell'893 capoluogo della nuova provincia bizantina di Longobardia, poi Catepanato d'Italia. La residenza barese del catepano, edificata alla fine del X secolo, sorgeva nell'area attualmente occupata dalla basilica di s. Nicola. Dalle fonti scritte si desume che esso comprendeva la dimora del catepano, alcuni uffici, un alloggiamento presumibilmente per la guarnigione della città, una prigione e le chiese e cappelle di S. Basilio, S. Sofia, S. Eustrazio, S. Demetrio. In questa fase l'abitato era contraddistinto da case di modeste dimensioni caratterizzate dalla presenza di una corte con pozzo. Fuori dell'abitato, vicino alle mura, nel 978 fu fondato il monastero di S. Benedetto, che svolgeva il fondamentale ruolo di collegamento tra il centro urbano e la campagna circostante. La dislocazione di monasteri ed edifici di culto e relative necropoli sembra attestarsi in zone periferiche a N della penisola (SS. Giovanni e Paolo, S. Pietro e S. Maria del Buon Consiglio). Al centro della città e collegata al porto vi era la cattedrale, demolita nel 1034 dall'arcivescovo Bisanzio per far luogo ad un nuovo edificio più grande, contestualmente al trasferimento a Bari del seggio episcopale di Canosa, la più antica città cristiana della Puglia, decaduta ad opera dei Saraceni. Nella zona ora occupata dal Castello vi erano una serie di abitazioni ed un piccolo edificio di culto di X secolo. Il porto era sul versante occidentale della penisola a breve distanza dall'episcopio. Nel 1071 i Normanni di Roberto il Guiscardo occupano la città spostando il potere politico dal ceto militare bizantino a quello mercantile e artigianale. Emblema di questi cambiamenti è la vicenda costruttiva della Basilica di S. Nicola, con il furto delle reliquie da Myra, i contrasti tra fazioni per la loro custodia ed infine la decisione di affidarle all'abate Elia e di erigere un nuovo edificio dedicato al santo proprio laddove sorgeva il pretorio bizantino, a partire dal 1089. In età normanna si registra anche la rivitalizzazione del porto in relazione alla Crociata ed il trasferimento in città dei proprietari terrieri dell'entroterra. Le fonti restituiscono per il XII l'immagine di una città composta da “vicinia”, aggregati di diverse abitazioni di famiglie con interessi comuni, disposte a cerchio intorno ad una corte con pozzo e viridarius, quasi delle isole autosufficienti difese dalle case più alte e dotate di torri. Ai vicinia si legano anche le chiese, spesso fatte costruire dai privati. Nel periodo all'inizio tormentato del regno di Ruggero II (1130-1154) la città si amplia sul versante S-O, dove una serie di abitazioni si installa ai lati della ruga Francigena (attuale Strada Gesuiti), che prende il nome dai pellegrini Franchi che passavano da Bari diretti ad Oriente. Nel 1156 la città, coinvolta in un tentativo di riconquista da parte dell'imperatore bizantino Manuele I Comneno, subisce la durissima punizione di Guglielmo il Malo che ne abbatte le mura e la rade al suolo quasi completamente: le abitazioni civili e le chiese private subirono notevoli danni, furono risparmiate la cattedrale e la basilica nicolaiana. Anche il castello, fatto costruire dai Normanni nell'XI secolo in posizione periferica ma non marginale, fu completamente distrutto. La ripresa della città si ebbe soltanto dieci anni dopo quando Guglielmo II accordò ai baresi il perdono. Nel 1177 l'arcivescovo Rainaldo si adopera per la ricostruzione e l'ampliamento della Cattedrale. A questo periodo risale anche la costruzione della Chiesa di S. Marco. Bari passò alla dinastia sveva nel 1194, quando Costanza di Altavilla, ultima erede della stirpe normanna, sposò Enrico VI, figlio di Federico Barbarossa. Durante la dominazione Sveva il castello è ricostruito ed ampliato da Federico II, in attuazione del suo vasto programma difensivo contro nemici interni ed esterni (1233-1240). La città continua ad espandersi in direzione S-E e le mura si estendono ad includere il nuovo quartiere cresciuto a sud della Giudecca, al quale si accede dalla nuova porta S. Lucia. Nel 1266 Carlo d'Angiò prende possesso del regno di Sicilia e quindi anche di Bari, dando avvio alla dominazione Angioina durante la quale la città si estende ulteriormente verso sud, raddoppiando il numero dei vicinia rispetto all'epoca precedente nonostante la recessione economica e la crisi demografica legata anche alle frequenti carestie. In questo periodo inizia la costruzione di cappelle ed altari per ospitare sepolture privilegiate presso cattedrale e basilica; mentre il castello modifica progressivamente la sua funzione da fortezza isolata a struttura militare integrata nella città, grazie ai lavori di ristrutturazione (1276-1280), che coinvolgono anche le mura. La città si arricchisce di edificio di culto e monasteri e tra le abitazioni, si diffondono le case palazziate a due piani e dotate di gayfo. Dopo la conquista del regno di Napoli da parte degli Aragonesi nel 1442 e ormai assoggettata al dominio feudale degli Orsini Principi di Taranto dal 1440, Bari conosce un periodo di relativa decadenza, aggravata anche dal terremoto del 1456. Gli Orsini creano un polo militare alternativo al Castello, il fortino s. Antonio sul porto, già esistente dalla metà del XIV secolo. Alla morte del principe, il ducato di Bari passa agli Sforza di Milano.
- Depalo M. R. , Bari, sotto la città. Luoghi della memoria, Bari, sotto la città. Luoghi della memoria, , Bari: , 2008
- Bertelli G.,S. Maria que est episcopio. La cattedrale di Bari dalle origini al 1034, S. Maria que est episcopio. La cattedrale di Bari dalle origini al 1034, , Bari: , 1994
- AA. VV., Tateo F. a cura di, Storia di Bari dalla preistoria al Mille, Storia di Bari dalla preistoria al Mille, , Roma-Bari: , 1989
- AA. VV., Tateo F. a cura di, Storia di Bari dalla conquista normanna al ducato sforzesco, Storia di Bari dalla conquista normanna al ducato sforzesco, , Roma-Bari: , 1990
Scheda
- BABIS000268
Tipologia del bene
Tipo: Città
Funzione:
- Sacra/religiosa/culto
- Produttiva/lavorazione/artigianale
- Difensiva/militare
- Portuale
- Abitativa/residenziale
Condizione Giuridica
Proprietà mista
-
Tipo: Soprintendenze ambito architettura-belle arti-paesaggio
Ente: SABAP-FG (Archite-BA-Pae)
Ruolo: Tutela e valorizzazione
-
Tipo: Soprintendenze ambito archeologico
Ente: Soprintendenza Archeologia della Puglia
Ruolo: Tutela e valorizzazione
-
elemento contenuto in - Sito Pluristratificato
Periodo:
- Età medievale (generico)
- Alto Medioevo (VII-X secolo)
- Basso Medioevo (XI-XV secolo)
Motivazione:
- Bibliografia
Cronologia specifica:
Dal: VII sec. d.C. Al: XV sec. d.C.
- Conservato parzialmente
Dimensioni in Mq: 300000.00
Criterio di perimetrazione: Evidenze da ortofoto
Tipo Fruibilità: Attrezzato per la fruizione