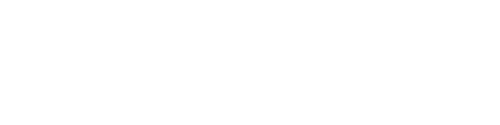Esplora la Carta
Gli Acaya restarono signori di Segine per tre secoli. Il feudo cambiò il nome in Acaya nel 1535-36, quando terminarono i lavori voluti da Gian Giacomo, “regio ingegnere militare” di Carlo V, che fortificò il centro e modificò il castello fatto edificare dal padre Alfonso nel 1506. Gian Giacomo volle una vera e propria ricostruzione del borgo, che ne fece uno dei migliori esempi di Rinascimento meridionale. La nuova cinta muraria, interamente difesa da fossati, venne rinforzata da bastioni angolari, uno dei quali era occupato dal castello. La fortificazione, realizzata in blocchi di calcare locale, si eleva scarpata fino al toro marcapiano che l'avvolge per tutto il perimetro e, al di sopra, prosegue verticale seguendo l'andamento delle cortine, fino ad innestarsi nelle torri angolari. Il fossato è scavato nel banco di roccia maturale. Alla cittadella si accede attraverso una porta realizzata nel 1535, che costituisce l'ingresso principale al borgo: a fornice unico, conserva ancora, all'interno degli stipiti, gli incassi litici del portone. L’impianto quadrangolare della nuova Acaya che, secondo il suo progettista avrebbe ospitato circa 1500 abitanti, era organizzato intorno a due assi perpendicolari che s’incrociavano nel punto in cui si apriva la piazza con la chiesa, nucleo di tutto l’abitato. Le strade, della medesima larghezza, disegnarono isolati stretti e lunghi occupati da case a schiera ad un piano. La chiesa, oggi matrice dedicata alla Madonna della Neve, conserva pochi elementi dell’edificio rinascimentale: un semplicissimo lavabo collocato nella sagrestia, un battistero in pietra conservato nella navata di sinistra, la tela sull’altare dell’Immacolata. Si conserva invece com’era nel Cinquecento il campanile, costituito da due corpi disposti ad elle. La costruzione è realizzata con conci “a punta di diamante” e decorata nella parte alta da valve di conchiglia, che talvolta sostituiscono gli archetti trilobati di gusto medievale. Un robusto fregio ad ovuli marca la sommità del campanile. A sinistra della porta d’ingresso al borgo, tra il bastione e la torre, si conserva una struttura alta m 2.5 ca. composta da blocchi in pietra, base per due colonne che dovevano reggere una campana d’allarme. Sulla facciata della struttura quattro cherubini disposti secondo due diagonali immaginarie, la cui intersezione è marcata da una rosetta in rilievo. L’attuale largo del castello era la piazza del borgo rinascimentale, con al centro vali silos per conservare il grano e un grande pozzo (dove oggi si vede una fontanina) a disposizione degli abitanti. La perfetta geometria dell’impianto urbano venne interrotta solo in corrispondenza del bastione opposto al castello dove, nel 1564, Gian Giacomo fece edificare un convento francescano per i minori osservanti dedicato a Sant’Antonio, poi ingrandito dai de’ Monti. L’edificio doveva avere una chiesa a navata unica, un piccolo chiostro e altri consueti ambienti conventuali (refettorio, celle, etc.); definitivamente perduti i pregevoli affreschi del 1568 eseguiti da Cesare di Martano. Alcuni elementi decorativi e strutturali sono ancora conservati: un arco con l’arme dei de’ Monti che immette in una cappella, una nicchia di fattura cinquecentesca, un basso corridoio con aperture (murate) intervallate da colonnine al piano superiore; degno di nota inoltre il giardino del convento, attualmente di proprietà privata, che conserva un blocco con l’arme più antica dei dell’Acaya, forse databile al XV secolo. Con la morte di Gian Giacomo dell'Acaya nel 1570, il feudo passò al Regio Fisco (1575) e successivamente fu acquistato da Alessandro de’ Monti (1608). Intorno alla metà del Seicento la chiesa era abbellita da diversi altari: l’altare maggiore, decorato da elegante fregio barocco e dalle armi dei Vernazza, l’altare del Rosario voluto da Alessandro de’ Monti, l’altare di Sant’Antonio da Padova, di Santa Maria “dello Spasimo” e di Sant’Angelo. Verso la fine del secolo, il feudo tornò alla Corte Regia, che lo vendette ai De Monti-Sanfelice (1688) che, a loro volta, lo vendettero quasi subito ai Vernazza. All’epoca il centro era ormai ridotto ad una borgata semidiroccata, assediata dalla malaria e rinnegata come residenza dai feudatari, che preferirono trasferirsi nella vicina Castrì. Risale alla metà del XVIII secolo la costruzione della cappella di San Paolo: la facciata è marcata da un frontone triangolare interrotto al centro da una croce. L'interno è ad aula unica rettangolare e conserva un modesto altare. Verso la fine del Settecento, forse nell’intento di incrementare le attività e la rendita agricola del feudo, i Vernazza rifecero la porta d’accesso alla cittadella, che venne sormontata dalla statua di Sant’Oronzo, copia in pietra della statua in rame sulla colonna della piazza Sant’Oronzo a Lecce. Sotto la statua, è l’arme cinquecentesca dei “Re di Napoli” proveniente da un tratto di mura abbattute e, a destra, quella dei dell’Acaya; in basso a sinistra la corrosa arme settecentesca dei Vernazza. L’arme dei de’ Monti si trova all’interno del secondo arco (a tutto sesto), che costituisce la porta. L’intercapedine tra i due archi ospita tre caditoie, dispositivi di offesa in caso di attacco nemico. Negli stessi anni i Vernazza rifecero il tratto di mura dove si apre il portale di accesso al castello e commissionarono l’altare rococò dedicato a Sant’Oronzo della chiesa matrice, opera dell’architetto Emanuele Orfano.
Definizione Ambito Culturale:
- Dato non disponibile
- Cazzato M., Lecce e il Salento 1, Atlante del Barocco in Italia, , Roma: De Luca Editori d'Arte, 2015
- Costantini A., Guida di Acaya. Città, campagna, Cesine, Guida di Acaya. Città, campagna, Cesine, , Galatina: Congedo Editore, 1990
Scheda
- LEBIS000053
Tipologia del bene
Tipo: Castello (ambito extraurbano)
Funzione:
- Difensiva/militare
- Abitativa/residenziale
Condizione Giuridica
Proprietà mista pubblica/privata
-
Tipo: Soprintendenze ambito archeologico
Ente: Sop. Archeologia Puglia
Ruolo: Tutela
-
Tipo: Soprintendenze ambito architettura-belle arti-paesaggio
Ente: Sop. Belle Arti BR-LE
Ruolo: Tutela
-
elemento contenuto in - Sito Pluristratificato
Periodo:
- Età moderna (XVI -XVIII secolo)
Motivazione:
- Analisi delle strutture
- Bibliografia
Cronologia specifica:
Dal: XVI sec Al: XIX sec
- Danno lieve
Criterio di perimetrazione: Si perimetra l'area racchiusa dalle mura cinquecentesche