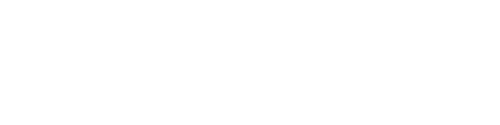Esplora la Carta
Le origini dell’attuale centro urbano di Campi Salentina vengono tradizionalmente fatte risalire ad un fenomeno di sinecismo a seguito dello spopolamento dei casali vicini, Afra, Bagnara, Firmigliano, Ainoli e Terenzano, che furono invasi e distrutti dai Saraceni nel 926 d.C., quando i profughi trovarono le condizioni ideali per la sopravvivenza e la difesa tra le aree boscose della conca. Probabilmente ad una fase caratterizzata dalla presenza di ripari temporanei o di abitazioni non strutturate, dovette seguire la costituzione di un primo nucleo strutturato. Le attività praticate dovevano consistere prevalentemente nell’agricoltura, nella caccia, nel commercio e nella concia delle pelli (a quest’attività vanno probabilmente collegati i due toponimi, ancora oggi utilizzati “Conza” – area di concerie, e Coira - depositi di curiame). Pochi sono i dati per la ricostruzione della storia della città, e quindi dell’evoluzione urbanistica del centro storico fino al XV secolo. Sappiamo che con la conquista normanna la città entra a far parte della Contea di Lecce e nel XII secolo divenne sede della diocesi, dopo che Tancredi d'Altavilla, re di Sicilia, fece dono della città al Vescovo di Lecce. Dopo l'epoca normanna, Campi passò sotto il dominio degli Svevi e intorno al 1220 la tradizione vuole che l'imperatore Federico II vi fece costruire un castello. Non ci sono documenti per questa fase, ma Campi doveva avere una qualche conformazione almeno a livello di organizzazione sociale, se nei documenti relativi alla reparatio castrorum (1241-1246), viene indicato che Campi doveva partecipare al restauro del castello di Brindisi. Benché non abbiamo ancora documenti certi sull’insediamento urbano, per l’età angoina iniziamo ad avere alcuni dati a livello documentario. Nel 1272, nei registri della Cancelleria Angioiana Campi viene definita ancora casale (insediamento rurale), al pari dei vicini centri di Squinzano e Novoli, e poco dopo, nel 1274, feudo. In questo periodo, coincidente con l’età comitale, Campi fu governata prima dai Capece (nel 1272 governava la città Giovanni, cui successe il figlio Pietro) e dal 1351 viene investito del feudo Raffaele Maremonti. Si può ipotizzare che in questo periodo si trattasse di un insediamento urbano a sviluppo eminentemente orizzontale, con case addensate lungo i principali assi viari che collegavano Lecce con Taranto e Campi con Squinzano e San Donaci e che costituiranno un elemento importante anche nei periodi seguenti per lo sviluppo della città. Fino all’insediamento della dinastia dei Maremonti non sembra che Campi giochi quel ruolo più significativo nello scacchiere della feudalità salentina, che inizierà invece a rivestire con questa famiglia e con quelle che le succederanno. Nel 1476 Ferrante d’Aragona conferisce l’autorità feudale sul casale di Campi a Filippo e Antonio Maremonti. Con i Maremonti, tra il XIV e il XV secolo, viene costruita, forse su un impianto più antico (testimoniato dall’affresco della Madonna col Bambino nella parte superiore dell’altare della Madonna del Rosario) la Chiesa di Santa Maria delle Grazie che diventerà Collegiata nel 1617. L’insediamento poteva concentrarsi già allora intorno a quella che ancora oggi è la piazza centrale in cui si accostano la Chiesa matrice e il Castello, secondo una organizzazione che si riscontra in molti centri storici del Salento.
Notizie storico-critiche:
- Nell'XI secolo con lo stabilirsi dei Normanni, Campi entrò a far parte della Contea di Lecce e divenne sede della diocesi, dopo che re Tancredi d'Altavilla fece dono della città al Vescovo di Lecce. Inizia, così, un lungo periodo feudale che si concluderà solo nel XIX secolo, che vide l'avvicendarsi a Campi di diversi signori. Dopo l'epoca Normanna Campi passò sotto al dominio degli Svevi e nel 1220 l'imperatore Federico II vi fece costruire un castello, che scelse come residenza estiva. Nel 1406 la città fu donata a Carlo Maremonti che ne divenne barone, e rimase di proprietà della famiglia fino al 1522. Fu in questo periodo che vennero apportate delle modifiche in stile prima medievale e poi cinquecentesco al castello.
- Maci C., Campi e il Salento. Storia, letteratura, arte, Ricerche e Studi in Terra d'Otranto, IV, Campi Salentina: , 1993
- Cazzato M., Lecce e il Salento 1, Atlante del Barocco in Italia, , Roma: De Luca Editori d'Arte, 2015
- Costantini A., AA. VV. a cura di, Viabilità e insediamenti in territorio di Campi, Ricerche e studi in Terra d’Otranto, IV, Galatina: Congedo Editore, 1990, 105-126
- Costantini A., Maci C. a cura di, Economia e territorio in Campi nella seconda metà del Settecento. Il Catasto Onciario del 1778, Campi e il Salento. Storia – Letteratura – Arte, in Ricerche e Studi in Terra d’Otranto, IV, Campi Salentina: , 1993, 237-283
- Palazzo L., AA. VV. a cura di, Dimora urbana e dimora rurale a Campi dal XVI al XVIII secolo, Città Viva, , Campi Salentina: , 1997
- Palazzo L., AA. VV. a cura di, Aspetti e problemi di storia dell’urbanistica di Campi. La casa a corte, L'Osservatorio, 3, Campi Salentina: , 1997
- Serio P., Serio P. a cura di, Attraverso dieci secoli di storia patria, Attraverso dieci secoli di storia patria, , Lecce: , 1963
- AA. VV., Vetrugno P. A. a cura di, Sequela Christi. Itinerari di spiritualità e frammenti di Arte Sacra a Campi Salentina, Sequela Christi. Itinerari di spiritualità e frammenti di Arte Sacra a Campi Salentina, , Lecce: , 1997
Scheda
- LEBIS000027
Tipologia del bene
Tipo: Città
Funzione:
- Sacra/religiosa/culto
- Frequentazione
- Produttiva/lavorazione/artigianale
- Abitativa/residenziale
Condizione Giuridica
Proprietà mista pubblica/privata
-
Tipo: Soprintendenze ambito architettura-belle arti-paesaggio
Ente: Sop. Belle Arti BR-LE
Ruolo: Tutela e valorizzazione
-
elemento contenuto in - Sito Pluristratificato
Periodo:
- Basso Medioevo (XI-XV secolo)
Motivazione:
- Bibliografia
- Conservato parzialmente
Criterio di perimetrazione: Il criterio per la perimetrazione del Centro Storico si basa sul confronto sistematico tra l'edificato presente nella Cartografia IGM al 25000 del 1949 e l'edificato della Cartografia IGM storica del 1870 disponibile in scala 1:50000.