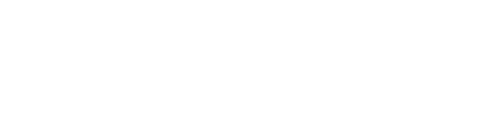Esplora la Carta
Città situata, nel Basso Tavoliere, non lontano dal tracciato della via Traiana e dal fiume Ofanto. Sulla base di sporadici ritrovamenti di reperti archeologici in siti che non coincidono con l’attuale insediamento, è stata proposta l’identificazione con il centro romano Cerina; in realtà, in mancanza di una continuità abitativa, è del tutto probabile che le origini di Cydiniola (ovvero Cidoniola) siano da inserire nel vasto quadro che registrò un notevole sviluppo di nuovi insediamenti in Capitanata fra i secoli XI e XII, come sembrerebbe confermare anche la leggenda legata al presunto ritrovamento miracoloso della cosiddetta Madonna di Ripalta, che riecheggia vari racconti simili riscontrabili nella regione. L’esistenza dell’insediamento, nel corso del XII secolo, è confermata indirettamente da varie fonti medievali. In epoca federiciana il centro aveva raggiunto una certa ricchezza, come si evince dal Quaternus excadenciarum Capitinate (un registro dei beni di proprietà del fisco imperiale, fatto redigere da Federico II intorno al 1249). Fra le poche vestigia medievali spiccano le chiese di Santa Maria delle Grazie e di San Francesco. Quest'ultima era la vecchia matrice e, sebbene trovi riscontri documentari solo in epoca moderna, risale almeno al XIII secolo, come sembra scaturire da fonti angioine indirette e dal recente rinvenimento di affreschi medievali; essa gravemente danneggiata in seguito al terremoto del 1731, conserva tracce delle strutture originali, di recente evidenziate a seguito di un intervento di restauro. Nella prima metà dell’Ottocento, parallelamente alla costruzione di una nuova cattedrale (cosiddetto duomo Tonti), si attuarono lavori di ampliamento che comportarono un’inversione dell’asse di orientamento dell’edificio, con la distruzione dell’abside e l’erezione di un coro poligonale. L’aspetto della chiesa è, pertanto, moderno con un’icnografia molto irregolare, frutto di varie fasi costruttive che hanno generato una serie di problemi statici, causa di una serie di restauri fra gli anni Settanta e Ottanta del XXI e il primo decennio di questo secolo: in occasione di questi ultimi, sono riemersi vari lacerti di intonaco affrescato. L’impianto presenta due navate, con una terza incompleta, ed è coperto da cupole (realizzate nel XVI secolo) e volte crociera. Sulla muratura della controfacciata, corrispondente alla originaria area presbiteriale, sono emerse tracce della decorazione a fresco medievale. La chiesa di Santa Maria delle Grazie (ovvero del Padreterno) sorge fuori dal nucleo originario dell’abitato, lungo la strada per Barletta; non è nota la data di fondazione, ma le origini medievali sono comprovate dal patronato della famiglia Lupi (o Luponi), documentata nel XIII secolo. La chiesa popolarmente è anche detta Incoronatella, in relazione alla festa campestre che vi aveva luogo l’ultimo sabato di aprile, come meta alternativa di pellegrinaggio per quanti non avessero la possibilità di recarsi al santuario dell’Incoronata presso Foggia. Dopo un lungo periodo di abbandono, sono stati completati, in anni recenti, i lavori di ristrutturazione dell’edificio e di restauro degli affreschi un contenitore di eventi culturali. La chiesa, a navata unica, presenta le pareti scandite longitudinalmente da arconi a tutto sesto mentre archi a sesto acuto segnano l’arco trionfale e l’arco absidale. Lungo i lati sono, poi, stati addossati altri ambienti: a est si segnala la cappella dell’Incoronata, edificata dalla famiglia Battaglino nel 1785, che ospita una statua lignea trecentesca della Vergine in trono. La decorazione pittorica, databile tra tardo XIV secolo e inizio del XV secolo, si concentra nella zona presbiteriale; sull’arcata trionfale si trova un ciclo della Passione di Cristo. Nell'abside si trovano immagini della Madonna del latte (o delle Grazie) e vari santi (Vito, Leonardo, Lucia) abbigliati elegantemente. All'interno del duomo si conserva la Madonna di Ripalta, proveniente dall’omonimo santuario campestre sito nei pressi della città e rinvenuto, secondo la leggenda, in una spelonca sulla riva del fiume Ofanto (ripa/riva alta). Si tratta di un raro esempio pugliese di dipinto su tavola tardoduecentesco che mostra la Vergine in trono con il Bambino a figura intera.
Notizie storico-critiche:
- Cerignola nacque verso il 500 a.C., quando Alessandro il Macedone fece distruggere l’antica Cerina, sul fiume Fortore, e gli abitanti scampati alla distruzione della città si spostarono in campagna, dando vita a vari piccoli borghi. In un secondo tempo, essi pensarono di riunirsi e di formare il nuovo paese di Cerignola. Scelsero come punto base il castello del Curatore romano, perché era il posto più sicuro, in quanto i cittadini potevano essere difesi e protetti dai soldati che stavano nel castello. Il Curatore era messo a guardia dei depositi di grano, che si trovavano nella zona che viene chiamata tuttora "Piano delle fosse". L’odierna Chiesa di San Domenico, sita nei pressi del "Piano delle fosse", era anticamente una stazione di cambio dei cavalli e di ristoro per i viaggiatori. L'antica Cerignola costituiva un insediamento di scambio sin dall'epoca romana. Ad avvalorare questa tesi sta il fatto che nell'arco di venti secoli, tutti o quasi, gli insediamenti antichi del Basso Tavoliere sono scomparsi per varie ragioni e vicende, mentre solo quello di Cerignola è giunto sino a noi. Una ragione in più che fa pensare all'origine romana dell'attuale impianto urbanistico del Borgo antico è data dal fatto che da un'attenta lettura del tessuto viario si evincono pochi elementi radiocentrici, bensì elementi di ortogonalità, tipici di tutti i centri di origine medievale impostati su schemi di preesistenze più antiche. In epoca medievale il borgo, ridotto a sede di feudo e dotato di castello e torri, fu chiuso entro mura di cinta turrite, con la popolazione asservita all'autorità del feudatario e del potere regio. Venne devastata nel quattordicesimo secolo, durante la guerra tra Giovanna Prima e Luigi di Ungheria. Nel 1414 prese le redini del trono Giovanna seconda e, nel1418, vendette Cerignola a Ser Gianni Caracciolo, suo favorito, che, insieme al Villaggio e territorio di Orta, pagò appena dodicimila ducati. Da questo momento Cerignola cessava di essere città regia e diventava feudo e patrimonio della famiglia Caracciolo. Con la morte di Carlo Caracciolo, avvenuta nel 1584 la baronia di Cerignola passò alla figlia Caterina, contessa di S. Angelo, la quale, dopo il matrimonio con il duca di Monteleone, Ettore Pignatelli nel 1611, cedette il feudo di Cerignola a favore di Girolama Pignatelli (sua figlia secondogenita). Da allora Cerignola rimase feudo dei Pignatelli. Il terremoto del 1731 causò notevoli danni: lo stesso castello, già modificato nel suo impianto originario, ne rimase semidistrutto. Nella seconda metà del Settecento si assiste alla ricostruzione degli edifici distrutti e ad un'ulteriore espansione fuori le mura del borgo antico ormai circondato completamente. Tale ricostruzione avvenne in modo irregolare e non uniforme, infatti molti dei vecchi edifici rimasero troncati dei piani superiori distrutti dal terremoto, altri invece vennero ricostruiti sulle macerie utilizzando i vecchi muri come fondazioni. L’abolizione del feudalesimo con la legge 2 agosto 1806 mise fine dopo 400 anni, alla dominazione dei baroni feudali sulla città. L'ultimo feudatario fu il Conte di Fuentes ed Egmont, Giovanni Armando Pignatelli. Con il riscatto delle terre feudali, con l'abolizione della Dogana e delle proprietà ecclesiastiche e con l'avvento dei Napoleone al Regno nell'Ottocento, al decollo agricolo-industriale delle campagne fece riscontro uno sviluppo notevole di Cerignola nel suo insieme. Per quanto concerne il borgo antico esso aveva ormai raggiunto la sua definitiva fisionomia, così come lo si può ancora osservare. Il nucleo antico di Cerignola conserva ancora oggi, quasi inalterata, la sua fisionomia di borgo medievale, costituendo quindi un patrimonio storico-culturale da rivalutare.
- Antonellis L., Cerignola - guida alla città, ,1999
- Gelao C., Puglia Rinascimentale : EDIPUGLIA, 2005
- Corsi P., Cerignola e la Capitanata all’epoca di Federico II: la testimonianza del Quaternus, Il territorio di Cerignola dall’età normanno-sveva all’epoca angioina, Atti del XIV Convegno Cerignola Antica, , Cerignola: , 2000
Scheda
- FGBIS000057
Tipologia del bene
Tipo: Città
Funzione:
- Produttiva/lavorazione/artigianale
- Abitativa/residenziale
Condizione Giuridica
Proprietà mista
-
Tipo: Soprintendenze ambito architettura-belle arti-paesaggio
Ente: Sop. Belle Arti BA-BAT-FG
Ruolo: Tutela e valorizzazione
-
elemento contenuto in - Sito Pluristratificato
Periodo:
- Basso Medioevo (XI-XV secolo)
Motivazione:
- Bibliografia
- Conservato parzialmente
- Integro
Criterio di perimetrazione: La perimetrazione è stata effettuata sulla base dell'ingombro delle strutture
Tipo Fruibilità: Attrezzato per la fruizione