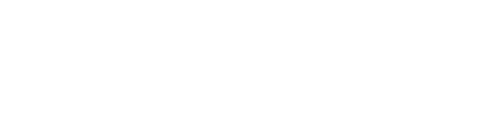Esplora la Carta
Foggia sorge nel cuore del Tavoliere, tra il torrente Celone e il fiume Cervaro, all'incrocio di importanti vie di comunicazione. La prima attestazione del casale Sancte Marie de Fogia, risalente al 1090, si riscontra in un documento che sancisce l'offerta dell'omonima chiesa alla basilica di San Nicola di Bari, da parte del duca Ruggero Borsa. Il territorio si presentava ricco di acquitrini, circostanza che ha favorito il sorgere della leggenda del rinvenimento miracoloso di una immagine della Vergine (cosiddetta Iconavetere), identificata con la tavola dipinta conservata tuttora nella cattedrale, che sarebbe all'origine della fondazione di una prima chiesa intorno alla quale si sarebbe sviluppata Fogia. Nel giro di pochi decenni Foggia divenne castrum e nei suoi dintorni si svilupparono vari sobborghi; ma apparteneva alla diocesi di Troia e il mancato raggiungimento della dignità vescovile fu motivo di aspre lotte fra il clero di Foggia e quello troiano. Durante il Medioevo sono attestate, oltre alla matrice di Santa Maria, varie chiese: la più antica risulta San Tommaso (sorta fra 1100 e 1125), alla quale si affiancarono, nel corso del XII secolo, Sant'Eleuterio, San Pietro, San Nicola iuxta villam Fogie, San Leonardo e Santa Cecilia. Nei secoli seguenti furono fondate altre chiese e cappelle cittadine, insieme a insediamenti extraurbani: es. San Lorenzo in Carminiano. La città occupava l'area del centro storico (cosiddetta "testa di cavallo", per la forma che ricorda una testa equina) tra le vie Manzoni, Fuiani, della Repubblica e corso Garibaldi, sviluppandosi irregolarmente intorno dalla via principale (attuale via Arpi) ed era divisa in vari quartieri (pittagia) e sobborghi. La città ebbe grande rilievo in epoca federiciana, quando assurse al ruolo di regalis sedes inclita imperialis; è nota la predilezione nutrita dall'imperatore svevo per la Capitanata, e per Foggia in particolare, che doveva apparire del tutto diversa rispetto all'attuale paesaggio arido e riarso dal sole, presentando ricchi boschi e frequenti specchi d'acqua: ambiente ideale per la caccia (una delle attività predilette da Federico II) e per le residenze di svago (domus solaciorum). La presenza della corte favorì lo sviluppo delle attività economiche nella città: la popolazione annoverava numerosi artigiani e comprendeva forestieri provenienti sia da altre città della penisola italiana, sia dall'estero. Il raggiungimento di tale rilievo amministrativo è stato favorito dalla particolare condizione giuridica della città, che rimase centro demaniale, evitando il processo di infeudamento. Nei dintorni di Foggia erano presenti, oltre ad altre domus, varie massarie regie, che rientravano in un ampio progetto di strutturazione demaniale della campagna. Nel Duecento la città conobbe il fervore artistico di alcuni fra i cantieri più importanti per la storia dell'arte pugliese: quelli della collegiata di Santa Maria (attuale cattedrale) e del palazzo imperiale, dai quali prese le mosse la cosiddetta “scuola di Foggia”, alla quale si legano i nomi del protomagister Bartolomeo e degli scultori Gualtiero e Nicola di Bartolomeo. Il palazzo è andato completamente distrutto: uniche vestigia ne restano un'epigrafe che celebra la fondazione, nel 1223, ad opera di Bartolomeo e l'archivolto di un portale monumentale (forse quello d'accesso), dalla fitta decorazione vegetale e due mensole a forma di aquila, incastonate presso Palazzo Arpi, attuale sede del Museo Civico. Sembra che l'edificio fosse situato nel centro antico della città, non lontano dall'attuale porta Arpi: è radicata convinzione della storiografia locale che una serie di ambienti sotterranei –siti nelle vicinanze del luogo in cui venne ritrovato l'archivolto e dove, nel noto disegno cinquecentesco della città conservato presso la Biblioteca Angelica di Roma, è riportato il «palazzo di Federico Imperador 2°» – ne celi i resti. Con l'avvento della dinastia angioina Foggia perse il ruolo di capitale del Regno, ma non quello di importante centro amministrativo della provincia. Alla predominante economia, incentrata sulla produzione e commercio di cereali, si era affiancato, alla fine del XIII sec., l'allevamento ovino ed era ripresa la transumanza tra Abruzzo e Tavoliere. Una chiesa dedicata a sancta Maria de Fogia (ovvero de Focis) è documentata nell'ultimo decennio dell'XI secolo; l'attuale edificio, con tutta probabilità, sorge sullo stesso sito e conserva alcune parti romaniche, riferibili alla fabbrica che, secondo una perduta epigrafe, venne fondata nel 1172. La ricca decorazione plastica fu realizzata in varie fasi da scandire fra XII e XIII secolo. All'interno della cattedrale si conserva una tavola dipinta che raffigura la Vergine con il Bambino, cosiddetta Iconavetere o Madonna dei Sette Veli, databile tra fine XI e inizi del XII secolo, oggetto di grande devozione. Il volto medievale della città, a prescindere dall'impronta lasciata dai vecchi quartieri alle strade che si dispongono irregolarmente ai lati di via Arpi, è perduto a causa dei danni provocati sia da vari terremoti avvenuti in epoca moderna (il più rovinoso dei quali nel 1731) sia dai bombardamenti subiti durante la seconda guerra mondiale.
- Licinio R., Masserie medievali. Masserie, massari e carestie da Federico II alla Dogana delle pecore : Adda Editore, 1998
- Jarussi Ugo, Foggia, genesi urbanistica, vicende storiche e carattere della città. : Adda Editore, 1975
- Haseloff A., Calò Mariani M.S. a cura di, Architettura sveva nell'Italia meridionale : Adda Editore, 1992
- Martin J.M., Foggia nel medioevo : Congedo Editore, 1998
- Casiglio N., La topografia di Foggia nel Medioevo, Archivio Storico Pugliese, XLVII, : , 1994
- Massimo G., La decorazione plastica della chiesa di Santa Maria nel Medioevo, La cattedrale di Foggia. Le sue forme nel tempo, , Foggia: , 2014
- Calò Mariani M.S. a cura di, Foggia medievale Foggia: , 1997
- Ventura A., Re mercanti braccianti: Foggia dai normanni alle lotte contadine Foggia: , 2004
Scheda
- FGBIS000011
Tipologia del bene
Tipo: Città
Funzione:
- Sacra/religiosa/culto
- Produttiva/lavorazione/artigianale
- Abitativa/residenziale
Condizione Giuridica
Proprietà mista pubblica/privata
-
Tipo: Soprintendenze ambito archeologico
Ente: Sop. Archeologia Puglia
Ruolo: tutela
-
Tipo: Soprintendenze ambito architettura-belle arti-paesaggio
Ente: Sop. Belle Arti BA-BAT-FG
Ruolo: Tutela e valorizzazione
-
elemento contenuto in - Sito Pluristratificato
Periodo:
- Basso Medioevo (XI-XV secolo)
Motivazione:
- Bibliografia
- Conservato parzialmente
- Ricostruito
Criterio di perimetrazione: La perimetrazione è stata effettuata sulla base dell'ingombro delle strutture
Tipo Fruibilità: Aperto al pubblico