Esplora la Carta
La cripta era un tempo sovrastata dalla chiesa di Santa Sofia, di cui rimane oggi notizia solo in antichi documenti ecclesiastici. Scavata nel banco roccioso tufaceo e collocata nel cuore del centro urbano, presenta due accessi: il principale da via Roma, attraverso un ingresso sormontato da un campanile a vela che conduce nell’invaso dedicato anticamente a Sancta Maria, oggi alla Madonna della Consolazione. Un secondo ingresso, già segnalato durante la visita pastorale del 1608, si apre invece su via Monticelli attraverso un portale cinquecentesco e venne realizzato dopo il crollo o l’abbattimento dell’abside. La struttura presenta un impianto basilicale a tre navate suddivise da cinque pilastri quadrangolari in pietra, più un sesto nella navata sinistra. Il sesto pilastro, crollato, è stato sostituito da una struttura metallica durante gli ultimi restauri. L’abside originale, di cui si vedono i resti sulla destra, fu sostituito dall’attuale affrescato. Presenta due absidi presbiteriali e nicchie laterali pseudorettangolari. Sorse verso l’XI-XII secolo e conserva vari affreschi di età medievale e moderna (XII – XVI secolo), nonché un altare cinquecentesco e un altare barocco in forme miniaturizzate con cornice in pietra quadrilobata al centro del paliotto. Entrando dall’ingresso principale, immediatamente a destra sulla parete occidentale, in una nicchia è stato ricavato un altare cinquecentesco con al centro la raffigurazione ad affresco di un’Annunciazione. L’affresco, palinsesto, ci presenta la Vergine sulla destra e l’Arcangelo inginocchiato a sinistra con sullo sfondo i resti di un edificio. La Vergine appartiene allo strato più profondo di intonaco, mentre l’Arcangelo a quello superiore; quindi i due affreschi, appartenenti a due fasi decorative differenti, rappresentano la stessa scena sacra. Non vi è traccia di iscrizione e l’affresco è in più parti rovinato. Nell’intradosso della nicchia formata dall’altare è rappresentato un cielo stellato con al centro il Sole in cui è una croce con un’iscrizione illeggibile. Sui piedritti, anch’essi affrescati, i dipinti sono completamente rovinati come sul lato destro, o solo in parte visibili come sul lato sinistro in cui rimane un Santo con barba e pastorale (forse un San Nicola). Un documento del 1608 attesta che questo altare era stato costruito non molto tempo prima dal devoto del luogo Andrea Arnone che si era riservato il diritto di sepoltura entro un sepolcro scavato ai piedi dell’altare. Sulla parete meridionale nelle prime due nicchie rimangono solo tracce di colore; nella terza vi è l’altare barocco, in cui è inserito il volto d’una Vergine con Bambino più volte ritoccato; il Bambino ha il nimbo crocesignato e il resto di tale affresco, databile alla fine del Quattrocento, è nascosto dall’altare. Nella parete orientale troviamo al centro, nell’abside centrale, un affresco votivo composto da tre riquadri. Al centro è rappresentato Cristo in trono, di grandi dimensioni, che regge su una delle ginocchia un libro aperto con iscrizione latina che riporta un passo del Vangelo di Giovanni “Io sono la luce del mondo, chi segue me non cammina nelle tenebre” (Gio, 8,12). A sinistra è rappresentata Santa Caterina d’Alessandria su sfondo tripartito con parte dell’iscrizione esegetica: la santa presenta la tradizione corona e sostiene la ruota dentata e la palma del martirio. A destra troviamo, su strato palinsesto, Sant’Antonio Abate che regge un Evangelio e un bastone dalla cui base escono lingue di fuoco. Ai suoi piedi si intravede un maialino, secondo l’iconografia occidentale che lo vede protettore degli animali domestici e del c.d. “fuoco di Sant’Antonio”. Nella parte inferiore dell’affresco due piccole figure in posizione orante, una maschile e una femminile, rappresentate su sfondo campestre: i committenti del trittico, datato alla metà del Seicento. A destra, nella prima nicchia-abside, è rappresentato un trittico: al centro è una Vergine in trono con Bambino, benedicente alla greca. La Vergine indossa una tunica bianca a cerchietti perlinati tipici del gusto popolare e alla sinistra del capo si legge la data del 1596 e l’iscrizione che la identifica come Madonna di Leuca; la Madonna sostiene il Bambino Gesù che con la destra benedice e con la sinistra sostiene il libro simbolo della buona novella; in basso sono rappresentati un uomo e una donna di dimensioni minori, i committenti dell’opera, identificati come il barone Giovanni Francesco Santabarbara e sua moglie Giuditta che comprò il feudo di San Cassiano da Vittoria Doria e lo tenne fino al 1602. A destra della Vergine troviamo un’altra raffigurazione di Maria nell’atto di allattare, immagine mariana spesso venerata proprio sotto il più breve titolo di Madonna della Consolazione, che rimanda alla Vergine protettrice delle puerpere; ai lati del capo resti d’iscrizione, ai piedi una piccola figura votiva maschile. A sinistra della Vergine un’altra Santa Caterina rappresentata nell’iconografia tradizionale, con palma del martirio e ruota dentata; sul capo vi è l’iscrizione esegetica ed ai piedi una figurina votiva femminile che regge il rosario. Sulla parete N, nella prima nicchia, è raffigurata una Vergine con Bambino. La Vergine regge il Bambino sul braccio destro; alla sua sinistra è l’iscrizione MATER in caratteri tipici dell’età angioina. Mentre il nimbo della Vergine è puntinato, quello del Bimbo è crocesignato. L’affresco, sebbene in più parti rovinato, soprattutto nella zona destra, è molto raffinato sia dal punto di vista compositivo sia dal punto di vista dell’attenzione ai particolari e può essere collocato nel XIII secolo. Nel corrispondente pilastro è raffigurata Santa Lucia che regge in una mano la palma e nell’altra un piatto in posizione verticale su cui sono dipinti due occhi; indossa un velo sui capelli e una veletta di tipo orientale scostata dal volto. Interessante l’immagine nella prima nicchia a sinistra nella parete N, raffigurante San Teodoro, l’affresco più antico della cripta risalente al XIII, se non alla fine del XII secolo. Il Santo, di cui si vede soltanto il volto, la criniera del cavallo, e un braccio che impugna una lancia, porta tra i capelli una corona di pietre preziose, indossa un omoforio (sorta di mantello) crocesignato sulle spalle e ha il nimbo giallo bordato di bianco; sulla destra è una lunga iscrizione in greco che identifica il Santo come stratega. Il suo culto era infatti molto diffuso nel Salento bizantino in quanto protettore delle armate bizantine che avevano il loro maggiore avamposto in Brindisi, città di cui il Santo è l’antichissimo protettore (fotografie pubblicate su autorizzazione dell'Arcidiocesi di Otranto del 9 luglio 2020).
Definizione Ambito Culturale:
- Dato non disponibile
- Abati V., San Cassiano : Lorenzo Capone Editore, 1987
- Fonseca C.D., Gli insediamenti rupestri medievali nel basso Salento, ,1979
- Cazzato M., Lecce e il Salento 1, Atlante del Barocco in Italia, , Roma: De Luca Editori d'Arte, 2015
- Peluso M., Peluso M. a cura di, Guida di San Cassiano, Guida di San Cassiano, , Galatina: Congedo Editore, 2012
Scheda
- LEBIU002147
Tipologia del bene
Tipo: Cripta
Funzione:
- Sacra/religiosa/culto
- Funeraria
Condizione Giuridica
Proprietà Ente pubblico territoriale
-
Tipo: Soprintendenze ambito archeologico
Ente: SABAP-LE (Archeologia)
Ruolo: Tutela e valorizzazione
-
Tipo: Soprintendenze ambito architettura-belle arti-paesaggio
Ente: SABAP-LE (Archite-BA-Pae)
Ruolo: Tutela e valorizzazione
-
elemento contenuto in - Sito
Periodo:
- Alto Medioevo (VII-X secolo)
- Basso Medioevo (XI-XV secolo)
- Età moderna (XVI -XVIII secolo)
Motivazione:
- Analisi delle strutture
- Analisi stilistica
- Bibliografia
- Conservato parzialmente
- Restaurato
Criterio di perimetrazione: Si permetra grosso modo l'area occupata dalla struttura.
Tipo Fruibilità: Aperto al pubblico
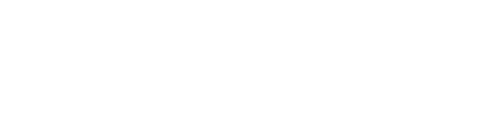








.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.JPG)
.jpg)