Esplora la Carta
L’acropoli di Monte Sannace ha restituito tracce di una prima frequentazione databile all’età del Ferro, tra il IX e l’VIII sec. a.C., indiziata da frammenti di ceramica di impasto e di incannucciato degli elevati delle capanne. Tale insediamento capannicolo è attestato prevalentemente nell’area D, uno dei punti di massima visibilità sull’area circostante, così come nell’area F. Nel primo caso, le indagini hanno messo in luce un grosso muro rettilineo associato ad una capanna che doveva avere un elevato in argilla e materiale stramineo deperibile. Tale frequentazione ha trovato ulteriori conferme che hanno rivelato come l’area sommitale del sito abbia svolto funzione difensiva e di aggregazione sociale, oltre che di luogo residenziale delle élites locali. A rafforzare l’idea che l’acropoli svolgesse un ruolo emblematico nell’ambito della topografia dell’insediamento contribuisce anche il fatto che nell’abitato in pianura non vi siano edifici di rilievo attribuibili a questa fase. Tale funzione si rafforza nel corso del VII-VI sec. a.C., fase cui sono ascrivibili importanti evidenze che consentono di inserire l’abitato acropolare di Monte Sannace nel contesto della Peucetia arcaica, oltre che all’interno dei dinamici rapporti tra popolazioni indigene e colonie magno-greche. Nell’area D, in una posizione eminente e centrale dell’acropoli, la presenza di un edificio di grandi dimensioni, di forma rettangolare e con zoccolo in pietra, doveva assolvere funzioni indubbiamente differenti rispetto alle coeve capanne. Molto verosimilmente si tratta di un megaron, ambiente di rappresentanza (forse privato) e funzionale allo svolgimento di incontri, riti e cerimonie. All’interno del vano più grande, sono state trovate le basi di due colonne del tetto, mentre un’antefissa con gorgoneion ritrovata negli scavi offre un’idea della decorazione del tetto. Questa interpretazione è avvalorata dal rinvenimento di frammenti ceramici di servizi da mensa, oltre che dalla presenza di un fornello. Le indagini stratigrafiche hanno individuato nuclei di capanne che in taluni casi hanno restituito materiale di gran pregio; in particolare, una capanna ubicata nel settore H (caratterizzata da uno zoccolo di pietre su cui si imposta un’intelaiatura lignea ed un incannucciato) ha permesso di individuare, oltre alla presenza di vasi interrati per uso domestico, un contesto ceramico, databile al VII-VI sec. a.C., composto da ceramica di produzione locale japigia, unita a ceramiche di importazione (prevalentemente corinzie) e subgeometriche coloniali. Tali attestazioni costituiscono uno termine cronologico alto dei contatti tra popolazioni peucete e coloniali (soprattutto di ambito metapontino, ancor prima che tarantino) o dell’opposta sponda adriatica. L’analisi dei frammenti ceramici ha consentito di individuare un servizio fine da simposio, molto probabilmente utilizzato per l’uso collettivo di bevande e/o cibi. Anche il settore G, posto nella porzione meridionale dell’acropoli, ha restituito tracce dell’abitato di capanne pertinente alla fase arcaica, come indicato, oltre che dal materiale ceramico, anche da lembi di battuto, buche di palo e coperture in rami e paglia. Nel corso del VI sec. a.C. l’abitato dell’acropoli si dota di ulteriori edifici, prevalentemente con funzione abitativa, muniti di zoccolo in pietra ed elevato in mattoni crudi e tetto in tegole. Tale impianto, che presenta un assetto urbanistico non ancora pianificato ed organizzato, perdura sino alla fine del VI sec. a.C., come si evince anche dall’analisi della viabilità, connotata da assi viari non rettilinei e orientati e che condizionano la disposizione delle case che li costeggiano. Interessante è il dato fornito da alcune tombe d’élites di VI sec. a.C. poste luoghi significativi della città alta. A poca distanza dal luogo in cui è stata rinvenuta la capanna di pregio, immediatamente a sud di essa, al centro dell’acropoli ed allineate lungo i suoi principali assi viari, sono collocate tre tombe a sarcofago, verosimilmente indice di un culto funerario legato a membri della società locale di cui preservare la memoria. Una delle tombe ha restituito un notevole esemplare di cratere a colonnette attribuito al Pittore di Memnon e visibile presso il Museo Archeologico Nazionale di Gioia del Colle. Altre tombe di gran pregio e caratterizzate da un notevole impegno decorativo sono state individuate a ridosso di una abitazione collocata nel settore G2. Il V sec. a.C. vive invece una evidente involuzione, con tracce di defunzionalizzazione (ad esempio all’interno del megaron viene impiantata una fornace) e non di nuove costruzioni, tranne nel caso di alcune “grandi tombe” nell’area D, al centro dell’acropoli. Il IV sec. a.C. segna un vero e proprio momento di svolta nell’assetto urbanistico dell’abitato: oltre alla costruzione delle mura di cinta, si osserva una razionalizzazione nell’organizzazione degli spazi abitativi e pubblici. Tale sistemazione si evince anche dalla presenza di assi viari che costituiscono la maglia urbana del centro. Le abitazioni attribuibili a questo periodo risultano più numerose e presentano caratteristiche di pregio che testimoniano una frequentazione almeno sino al III sec. a.C. Nella maggioranza dei casi le abitazioni di questa fase sono edificate ex-novo, obliterando quindi le strutture preesistenti; in questo periodo si diffonde una specifica tipologia abitativa, la cosiddetta casa “a pastas” con cortile, secondo un modello attestato in Grecia e in area messapica. Case di questo tipo sono state individuate su tutto il pianoro dell’acropoli di Monte Sannace. Spicca inoltre una casa “a peristilio”, dotata di colonne ed elementi architettonici in tufo e terracotta, posta in posizione eminente e rappresentativa dello status sociale dei proprietari. Da osservare la costruzione di un recinto sacro nel settore H dove, in età del Ferro, era presente una capanna di prestigio e che in questa fase svolge un ruolo sacrale con uno o più edifici di culto, degni di essere cinti e racchiusi. Alla seconda metà del III sec. a.C. è ascrivibile un repentino e violento evento che sconvolge l’ordine sociale e l’urbanistica del centro, come si rileva dalla rioccupazione di edifici un tempo luogo di culto o di sepoltura ed è verosimilmente da mettere in relazione con eventi bellici e nuovi equilibri politici tra Roma, le colonie magno-greche e le popolazioni indigene. Le ultime tracce di vita sull’acropoli sono attribuibili al I sec. a.C., come testimoniato dai ritrovamenti archeologici effettuati in case ellenistiche del settore G3 o dal reimpiego di materiale per una iscrizione funeraria databile ad epoca tardo-repubblicana. Tracce sporadiche di presenza umana sono rappresentate da alcuni frammenti ceramici databili al IV sec. d.C., oltre che da una chiesetta medievale intitolata a S.Angelo.
Definizione Ambito Culturale:
- Dato non disponibile
- AA. VV., Monte Sannace. Città dei Peuceti : Progedit snc, 2001
- Donvito A., Monte ìSannace. Archeologia e storia di un abitato peuceta : Schena Editore, 1990
- Ciancio A., Monte Sannace: gli scavi dell'acropoli (1978-1983), Monte Sannace: gli scavi dell'acropoli (1978-1983), , Galatina: Congedo Editore, 1989
- Ciancio A., Guida al parco archeologico di Monte Sannace, Guida al parco archeologico di Monte Sannace, , Bari: Progedit snc, 2001
- Galeandro F., Chelotti M. a cura di, Gli scavi della Scuola di Specializzazione in Beni archeologici dell'Università degli Studi di Bari sull'acropoli di Monte Sannace (1994-2001), Epigrafia e Territorio. Politica e Società. Temi di antichità romane, IX, Bari: EDIPUGLIA, 2013
- Amatulli A., Denti M. a cura di, Monte Sannace (Bari): un caso di contatto tra Peucezia e costa ionica, La céramique dans les contextes archéologiques "mistes". Questions de méthodologie, typologie, terminologie., , Rennes: , 2016
Scheda
- BABIU002656
Tipologia del bene
Tipo: Frequentazione
Funzione:
- Sacra/religiosa/culto
- Pubblica
- Abitativa/residenziale
Proprietario: Non disponibile
Condizione Giuridica
Proprietà Stato
-
Tipo: Ente MiBAC
Ente: Polo Museale della Puglia
Ruolo: Tutela e valorizzazione
-
elemento contenuto in - Complesso Topografico
Monte Sannace - acropoli (dall' età del Ferro ad ellenistica) - BABIC000215
Periodo:
- Età del Ferro (generico)
- Età Arcaica (VII-VI sec. a.C.)
- Età Classica (V-IV sec. a.C.)
- Età Ellenistica (IV-I sec. a.C.)
Motivazione:
- Analisi dei materiali
- Analisi delle strutture
- Bibliografia
Cronologia specifica:
Dal: IX sec. a.C. Al: I. sec. a.C.
- Conservato parzialmente
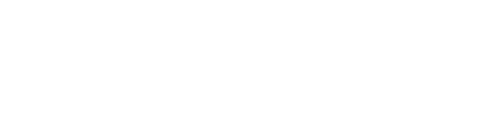








.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)