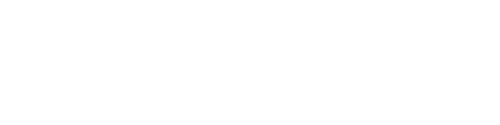Esplora la Carta
Il nome di Torre Alemanna compare, come riferimento topografico, in un documento del Codice Diplomatico Barlettano del 1334. Nella delimitazione dei confini di una proprietà si fa riferimento ad una "viam qua itur a Turri de Alamagnis". In documenti più tardi, ma anche nella cartografia di epoca moderna, il luogo è spesso citato con il toponimo Torre de la Manna. Per essere già nota in quell'epoca significa che essa esisteva da tempo. L'appellativo di Alemanna rinvia inoltre ai suoi fondatori, i Cavalieri Teutonici, ai quali Federico II donò (come attestano documenti del XIII secolo) delle terre presso Corneto, antico borgo medievale (distrutto nel 1349, nel corso delle guerre dinastiche che videro opposti Giovanna I d'Aragona e Carlo III di Napoli), i cui resti distano difatti poco più di un chilometro dal complesso. Il complesso di Torre Alemanna, è ritenuto dagli storici il più fiorente delle balie teutoniche in Puglia. Un centro talmente ricco (fra il XIV ed il XV secolo, possedeva oltre 2.800 ettari di terre) da consentire con la sua produzione zootecnica e cerealicola il sostentamento anche di San Leonardo di Siponto, da cui dipendeva, e degli altri insediamenti pugliesi aventi perlopiù valenza strategica e politica. L'intero possedimento fu nel 1483 ceduto dai Cavalieri alla Chiesa che, trasformandolo in Commenda concistoriale, lo gestì per mezzo di procuratori. Qualche decennio dopo, nel 1525, Leandro Alberti descrive il monumento come meta di pellegrinaggi da parte di ex prigionieri che vi portavano ex-voto in onore di San Leonardo, ma al momento della visita il complesso appare in stato di abbandono ed a rischio di rovina. Appare molto probabile che in questo arco di tempo la comunità di Torre Alemanna visse una fase di transizione tale da determinarne un processo di degrado e trasformazione dell'originario assetto, così come si era stratificato nel corso del XIII e XIV secolo. Torre Alemanna appare oggi come un complesso masseriale dotato, per l'appunto, di una torre d'avvistamento a pianta quadrangolare di circa 10 metri di lato e 24 di altezza e di una serie di corpi di fabbrica edificati nel corso dei secoli per ospitare numerose destinazioni d'uso (residenziale, produttiva e di culto). Il vano di piano terra della torre, la cui altezza si estende fino al livello del 1° piano del complesso, è coperto con volta a crociera costolonata poggiante su quattro colonnine con capitelli gotici "a crochet”. Esso, pregevolmente affrescato su tre lati e caratterizzato da un arco trionfale sulla parete ovest, è stato da sempre ritenuto una preesistente cappella, sulle cui mura, opportunamente raddoppiate, fu eretta la torre. La scoperta degli affreschi, datati alla seconda metà del XIII secolo, avvenne nel corso dei primi lavori di restauro nel 1989. Con il proseguo dei lavori (1997-2000), operando alcuni saggi conoscitivi all'interno dei muri, si è in realtà constatato che le modanature dell'arco trionfale svoltano nella muratura verso ovest rivelando che si tratta del presbiterio a pianta quadrata di una chiesa, probabilmente cistercense, la cui navata è oggi riconoscibile nella parte adiacente sul lato ovest. Inoltre, gli scavi archeologici operati nel 2003 nel presbiterio stesso hanno rivelato la preesistenza di un'ulteriore abside da relazionare ad una chiesa ancor più antica. Dunque è plausibile l'ipotesi che i Cavalieri, venuti in possesso dei terreni, abbiano eretto una torre sui resti di una chiesa edificandone, qualche decennio più tardi (XVI secolo), una nuova (oggi ancora esistente) dedicata prima a Santa Maria dei Teutonici, poi a San Leonardo. Fra il 1998 ed il 2000, contemporaneamente ai restauri effettuati alla Torre, vennero condotte indagini archeologiche all'esterno della struttura fortificata. Il piano superiore aveva tre finestre molto piccole. qui si trova anche l'ingresso originario. L'edificio semi-interrato individuato nei saggi condotti all'esterno Nord (un vero e proprio "butto") ha restituito ceramiche e vetri databili al XII secolo, mentre quello individuato nei saggi all'esterno Est materiali (ceramiche, vetri ed un tesoretto di monete in bronzo) di XIV secolo. All'esterno Ovest del complesso, inoltre, è stata rinvenuta la camera di combustione di una fornace in mattoni per la produzione di laterizi ed una discarica di scarti di varie attività produttive.
Notizie storico-critiche:
- Il nome di Torre Alemanna compare, come riferimento topografico, in un documento del Codice Diplomatico Barlettano del 1334. L’appellativo di Alemanna rinvia inoltre ai suoi fondatori, i Cavalieri Teutonici, ai quali Federico II donò delle terre presso Corneto, antico borgo medievale i cui resti distano difatti poco più di un chilometro dal complesso.
- L’intero possedimento fu ceduto nel 1483 dai Cavalieri alla Chiesa che, trasformandolo in Commenda concistoriale, lo gestì per mezzo di procuratori. Qualche decennio dopo, nel 1525, Leandro Alberti descrive il monumento come meta di pellegrinaggi da parte di ex prigionieri che vi portavano ex-voto in onore di San Leonardo, ma al momento della visita il complesso appare in stato di abbandono ed a rischio di rovina.
- E' plausibile l’ipotesi che i Cavalieri, venuti in possesso dei terreni, avessero eretto una torre sui resti di una chiesa edificandone, qualche decennio più tardi (XVI secolo), una nuova (oggi ancora esistente) dedicata prima a Santa Maria dei Teutonici, poi a San Leonardo.
- De Vita R., Castelli, torri ed opere fortificate di Puglia : Adda Editore, 1982
- Haseloff A., Architettura sveva in Italia meridionale, 1992
- Calò Mariani M.S., Cavalieri Teutonici in Capitanata. L’Insediamento di Torre Alemanna : Litograf, 2004
- Licinio R., Masserie Medievali. Masserie, massari e carestie da Federico II alla Dogana delle pecore : Adda Editore, 1998
Scheda
- FGBIU000283
Tipologia del bene
Tipo: Torre
Funzione:
- Difensiva/militare
Condizione Giuridica
Proprietà Ente pubblico territoriale
-
Tipo: Soprintendenze ambito archeologico
Ente: Sop. Archeologia Puglia
Ruolo: Tutela
-
elemento contenuto in - Complesso Topografico
Periodo:
- Età moderna (XVI -XVIII secolo)
- Età contemporanea (XIX-XXI secolo)
- Basso Medioevo (XI-XV secolo)
Motivazione:
- Bibliografia
- Restaurato
Tipo Fruibilità: Attrezzato per la fruizione